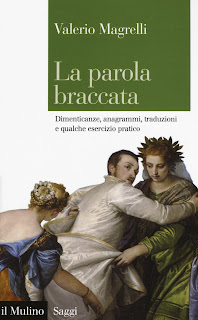Il continente dei Translation and Interpreting Studies (TIS) si sta allargando sempre più. La formula fortunata, inaugurata negli anni Settanta con James S Holmes e poi potenziata, fa da cornice a un universo crescente di una miriade di pubblicazioni, ricerche, speculazioni e finanche scommesse teoriche che coinvolge necessariamente un insieme largo di discipline, che va dalla linguistica alle neuroscienze e che chiaramente non si limita a riguardare lo stato delle cose nell'ambiente a volte un po' triste delle humanities (o digital humaties) bazzicato anche da questo blog, ma si allarga a una pluralità di settori e applicazioni davvero considerevole. Pensiamo anche ai software o alle piattaforme digitali che ogni giorno frequentiamo e che aprono la porta a una branca di questi studi che potremmo far ricadere nella terminologia (esemplificando: come si arriva a tradurre il "Save as" del menu "File" dei vari software con "Salva con nome" in italiano, "Enregistrer sous" in francese, "Guardar como" in spagnolo e così via?). I famosi contenuti di cui è sovrappopolata la rete - content is king, voleva la celebra massima - viaggiano dentro interfacce che sono sostanzialmente identiche nel funzionamento e nell'aspetto grafico e che mutano quasi esclusivamente l'ambiente linguistico che le accoglie. Tornando alla traduzione nell'ambito delle nostre humanities, fortunatamente non si parla più, già nella formula di cui dicevamo in partenza, di traduzione soltanto e ancora più fortunatamente pare siano ora un lontano e brutto ricordo espressioni aberranti che andavano per la maggiore fino a qualche tempo fa, quando si parlava di traduzioni "belle e infedeli" o "brutte e fedeli". Capire come si sia arrivati a questi mostri concettuali sarebbe un percorso a parte, interessante e significativo per comprendere le scorribande del pensiero umano, ma non è ciò che interessa primariamente a Valerio Magrelli nel volume La parola braccata. Dimenticanze, anagrammi, traduzioni e qualche esercizio pratico pubblicato da Il Mulino (pp. 224, euro 20). Questo libro si pone lo scopo di avvicinarsi a cosa accade nella mente in quel momento di sforzo prolungato nel quale volgiamo qualcosa da una lingua a un'altra. Davvero la traduzione è un atto, una scelta, un bivio continuo tra i più complessi che riguardino l'umano. Allo stesso tempo, vuoi per i ritmi elevati dei processi produttivi a cui le stesse traduzioni sono sottoposte, incluse chiaramente quelle letterarie, vuoi perché tutto rischia di non incuriosire più, l'evento mentale della traduzione, ad un livello di sentire comune, passa spesso in secondo piano, per quanto restino chiare a tutti le fondamentali implicazioni culturali, politiche e ideologiche di qualsiasi traduzione passata presente e futura sulla faccia della terra.
La parola "braccata" del titolo è quella cercata da chi traduce e si trova magari a vivere la sensazione di avere quella parola ricercata "sulla punta della lingua". L'immagine del titolo è venatoria, perché braccare vuol dire anche stanare una preda per spingerla verso il cacciatore. Allo stesso tempo è un'immagine territoriale perché territoriale è qualsiasi traduzione. Eppure, come dice il sottotitolo, a Magrelli interessano le esitazioni, gli imbarazzi e persino le dimenticanze, ossia quel che resta sulla punta della lingua e non si scioglie in una scelta traduttoria precisa. Insomma, il traduttore non è un cacciatore. Per impostare il proprio ragionamento, più che rifarsi alla gran matassa dei "TIS" di cui sopra, Magrelli torna a Benvenuto Terracini lettore di Agostino e alla considerazione di quel fragile ponte che si instaura tra la presenza di un originale (il testo da tradurre) e l'assenza di qualcosa di nuovo (il testo tradotto) e che sfocia nella concezione di una traduzione come processo di rammemorazione.
Il volume, introdotto da un'utile prefazione che intende collocare questo contributo nel grande panorama degli studi sulla traduzione, si sviluppa in due parti. La prima, di carattere concettuale come l'introduzione, asseconda il desiderio di "indagare le affinità fra l'atto traduttorio e alcune forme di attività mnestica, a cavallo fra competenze linguistiche e procedure attivate nell'atto del ricordo". I numi tutelari, oltre al già ricordato Terracini, restano Luciano Anceschi e l'imprescindibile Emilio Mattioli, e la casistica qui trattata abbraccia sollecitazioni da Saussure, Freud, Lurija, George Eliot, William James, Douglas R. Hofstadter o dal sinologo svizzero Jean François Billeter. Ricalcando Nabokov dei Problems and Poems (1969), Magrelli chiama Problemi questa prima parte. La seconda parte del volume, quella dei Poemi (parola preferita a "Poesie" per l'evidente allitterazione dell'originale nabokoviano), si limita a dei rilievi tratti dall'esperienza e agli esercizi pratici di cui ci rende partecipi il sottotitolo di questo libro. Ecco allora esercizi di capo o acrostici, esercizi di coda o rime, esercizi di verso o metro, esercizi di cifra in un indovinello, esercizi di segno o calligrammi (come tradurre la forma delle lettere?). Il finale, proprio per distoglierci dall'ambiente della sola letteratura, ci porta tra gli esercizi di tempo o sottotitoli, peculiare vicenda di traduzione per il cinema. L'impostazione del volume, sicura e rabdomantica al tempo stesso, giova al nucleo di problematicità affioranti e fluttuanti pagina dopo pagina e anche a quel nucleo di questioni che rimane inevitabilmente e giustamente sottotraccia, quando si affronta questo tema spinoso eppure potenzialmente estatico.
Visualizzazione post con etichetta Emilio Mattioli. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Emilio Mattioli. Mostra tutti i post
lunedì 17 settembre 2018
giovedì 11 gennaio 2018
"Il problema del tradurre" di Emilio Mattioli: dal "si può tradurre?" al "come si traduce?" e "che senso ha il tradurre?"
Nell'ultimo libro di poesia di Guido Mazzoni intitolato La pura superficie (Donzelli), uno degli aspetti più interessanti (e rilevanti, a mio avviso, anche a livello teorico) è il momento dedicato alla "traduzione" da Wallace Stevens. Ho virgolettato "traduzione" perché più che una traduzione quei momenti del nuovo libro rappresentano veri rifacimenti, riscritture o raschiature per arrivare ad altro. Eppure, di fondo, c'è il testo di partenza di Stevens. A partire da queste poesie Mazzoni ha compiuto tagli, adattamenti, integrazioni oppure si è soffermato su traduzioni ritenute chiaramente inesatte o incomplete, eppure per lui più convincenti di un lavoro di traduzione comunemente inteso. Allora non si può parlare di traduzione per questi testi proposti da Mazzoni; si tratta di altro materiale, dove la parola di Stevens entra, esce e rientra come un abbrivio lontano e sperso, che tuttavia permane. La proposta testuale e linguistica di Mazzoni su Stevens non potrebbe allora mai incontrare l'aspettativa media che si ha per una traduzione di una poesia scritta da un poeta di lingua straniera diversi anni fa. L'aspetto singolare e curioso è però che tutte queste considerazioni dialogano intimamente e possono benissimo uscire rafforzate dalla lettura di un libro puramente centrato sulla traduzione quale è Il problema del tradurre (1965-2005) di Emilio Mattioli, volume pubblicato recentemente da Mucchi Editore e radunante diversi scritti dello studioso di estetica, retorica a e traduttologia (pp. 200, euro 15, a cura di Antonio Lavieri). Il volume è chiuso da una postfazione di Franco Buffoni, con il quale Mattioli animò la rivista "Testo a fronte", ancora oggi luogo e strumento di prassi prominente della traduzione poetica, pratica dimenticata nella poeticissima penisola. Ed è proprio il punto di vista della prassi a interessare trasversalmente Mattioli in questi saggi densi e preziosi sparsi su quattro decenni. Perché se da un lato si può partire ad affermare con Croce che la traduzione non è possibile, la realtà della traduzione si dà invece quotidianamente da secoli ed è da questo dato di realtà che bisognerebbe continuamente ripartire per fondare una riflessione teorica che sia effettivamente utile alla prassi, com'è quella di Mattioli.
Il volume segna un passo importante perché per la prima volta è raccolta sotto un'unica rilegatura la principale produzione saggistica che Mattioli ha dedicato ai temi della traduzione (e della traduzione poetica in particolar modo). Le diverse posizioni sulla traduzione espresse da Croce, Gentile, Jakobson, Mounin, Dal Fabbro, Cicerone, San Girolamo, Anceschi e poi le riflessioni di autori come Novalis, Leopardi, Eliot, Pound, Celan o Ungaretti sono a più riprese chiamate in causa da Mattioli in questi contributi che, senza circonvoluzioni, affrontano di petto i temi chiave della traduzione, dal ricorrere dei luoghi comuni con cui ci si riferisce all'atto del tradurre (pensiamo solo al binomio fedeltà-infedeltà), all'effettiva incidenza di un pensiero traduttologico sulla stessa realtà della creazione poetica tout court. La sensazione è però sempre quella che parlando di traduzione si parli di uno dei problemi centrali della contemporaneità e non certo al solo piano letterario. Con il saggio del 1965 "Introduzione al problema del tradurre" Mattioli fu il primo a preparare adeguatamente il terreno alla riflessione sulla traduzione, che per Mattioli non rappresenta l'attività di volgere un testo da una lingua A a una lingua B, bensì l'attività chiave per avvicinarsi a qualsiasi problema di comprensione di senso di un'epoca. Il suo percorso attraverso i secoli mostra chiaramente come si sia intesa la traduzione nelle diverse epoche (dall'assimilazione degli antichi all'imitazione stilistica leopardiana, fino al gran bazar di modi di intendere la traduzione nel Novecento). Oggi non è facile raccogliere la portata dell'eredità e del gesto filosofico di Emilio Mattioli: in un'epoca storica drogata di teoria linguistica, dove spesso si arrivava a gingillarsi sui falsi problemi dell'impossibilità della traduzione, Mattioli partì da un'opzione filosofica centrata sull'osservazione che si è sempre tradotto e si continuerà a farlo finché ci saranno lingue diverse. Ha saputo spostare l'asse di domande probabilmente inutili e pretestuose come "si può tradurre?" a domande più cariche di conseguenze teorico-pratiche quali "come si traduce?" o "che senso ha il tradurre?".
Laddove Mattioli parla della traduzione come genere letterario, dopo aver posto l'attenzione sull'orizzonte della comprensione che precede quello delle scelte del traduttore, conclude che la traduzione è un genere letterario particolare "caratterizzato dal rapporto dialettico tra la poetica dell'autore tradotto e quella del traduttore". Si intravedono le parole-chiave che Mattioli ha disposto sulla tavola e che un'esperienza lunga come quella della rivista "Testo a fronte" ha via via perlustrato: poetica, intertestualità, ritmo, movimento del linguaggio nel tempo e avantesto. Sono tutti punti cardinali dove continuamente si riorienta la trattazione di Emilio Mattioli finalmente leggibile negli scritti di questo volume, dal fondamentale contributo del 1965 già ricordato all'altrettanto importante scritto del 2002 sui capisaldi della riflessione traduttologica rappresentati da Ricœur e Meschonnic, fino agli ultimissimi scritti del 2004 e 2005, di poco antecedenti la morte dello studioso avvenuta nel 2007 (sull'importanza capitale della riflessione di Henri Meschonnic un rinvio possibile è questo articolo disponibile qui).
Il volume segna un passo importante perché per la prima volta è raccolta sotto un'unica rilegatura la principale produzione saggistica che Mattioli ha dedicato ai temi della traduzione (e della traduzione poetica in particolar modo). Le diverse posizioni sulla traduzione espresse da Croce, Gentile, Jakobson, Mounin, Dal Fabbro, Cicerone, San Girolamo, Anceschi e poi le riflessioni di autori come Novalis, Leopardi, Eliot, Pound, Celan o Ungaretti sono a più riprese chiamate in causa da Mattioli in questi contributi che, senza circonvoluzioni, affrontano di petto i temi chiave della traduzione, dal ricorrere dei luoghi comuni con cui ci si riferisce all'atto del tradurre (pensiamo solo al binomio fedeltà-infedeltà), all'effettiva incidenza di un pensiero traduttologico sulla stessa realtà della creazione poetica tout court. La sensazione è però sempre quella che parlando di traduzione si parli di uno dei problemi centrali della contemporaneità e non certo al solo piano letterario. Con il saggio del 1965 "Introduzione al problema del tradurre" Mattioli fu il primo a preparare adeguatamente il terreno alla riflessione sulla traduzione, che per Mattioli non rappresenta l'attività di volgere un testo da una lingua A a una lingua B, bensì l'attività chiave per avvicinarsi a qualsiasi problema di comprensione di senso di un'epoca. Il suo percorso attraverso i secoli mostra chiaramente come si sia intesa la traduzione nelle diverse epoche (dall'assimilazione degli antichi all'imitazione stilistica leopardiana, fino al gran bazar di modi di intendere la traduzione nel Novecento). Oggi non è facile raccogliere la portata dell'eredità e del gesto filosofico di Emilio Mattioli: in un'epoca storica drogata di teoria linguistica, dove spesso si arrivava a gingillarsi sui falsi problemi dell'impossibilità della traduzione, Mattioli partì da un'opzione filosofica centrata sull'osservazione che si è sempre tradotto e si continuerà a farlo finché ci saranno lingue diverse. Ha saputo spostare l'asse di domande probabilmente inutili e pretestuose come "si può tradurre?" a domande più cariche di conseguenze teorico-pratiche quali "come si traduce?" o "che senso ha il tradurre?".
Laddove Mattioli parla della traduzione come genere letterario, dopo aver posto l'attenzione sull'orizzonte della comprensione che precede quello delle scelte del traduttore, conclude che la traduzione è un genere letterario particolare "caratterizzato dal rapporto dialettico tra la poetica dell'autore tradotto e quella del traduttore". Si intravedono le parole-chiave che Mattioli ha disposto sulla tavola e che un'esperienza lunga come quella della rivista "Testo a fronte" ha via via perlustrato: poetica, intertestualità, ritmo, movimento del linguaggio nel tempo e avantesto. Sono tutti punti cardinali dove continuamente si riorienta la trattazione di Emilio Mattioli finalmente leggibile negli scritti di questo volume, dal fondamentale contributo del 1965 già ricordato all'altrettanto importante scritto del 2002 sui capisaldi della riflessione traduttologica rappresentati da Ricœur e Meschonnic, fino agli ultimissimi scritti del 2004 e 2005, di poco antecedenti la morte dello studioso avvenuta nel 2007 (sull'importanza capitale della riflessione di Henri Meschonnic un rinvio possibile è questo articolo disponibile qui).
On parle de:
Antonio Lavieri,
Emilio Mattioli,
Franco Buffoni,
Il problema del tradurre,
Mucchi Editore
Iscriviti a:
Post (Atom)