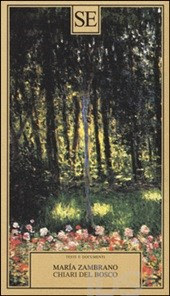La guerra civile americana, che imperversò tra il 1861 e il 1865, fece più di 600.000 morti. È un dato impressionante, sul quale non si ritorna mai a sufficienza. Ci sono i presupposti per dire che la "morte di massa", categoria che fu impiegata per la prima volta per la Prima guerra mondiale da Pierre Chaunu, ebbe un prodromo rilevante anche in quel conflitto. Ed è curioso che il libro più celebre su quel conflitto non sia stato scritto da chi ne ebbe esperienza diretta, ma da quello Stephen Crane che nacque a Newark nel 1871 e morì per le complicazioni della tisi in un sanatorio della Foresta Nera nel 1900. The Red Badge of Courage, uscito nel 1894, ebbe infatti da subito un impatto straordinario e un successo enorme. Chi di quella guerra aveva esperienze e lo lesse rimase impressionato: come poteva una persona nata sei anni dopo la fine del conflitto ricreare con grande rigore e vividezza la situazione fisica, psicologica e anche paesaggistica di un battaglione di soldati? come era possibile farlo seguendo prevalentemente il profilo del protagonista, "il giovane" (come lo chiama il narratore) "Henry Fleming" (come lo chiama qualche commilitone). Un'analisi dell'opera in odore di strutturalismo indugerebbe ancora sulla coppia antitetica data da coraggio e paura, l'asse su cui effettivamente scorre l'opera. Sappiamo, non sono più tempi buoni per lo strutturalismo, anche se non sarà tutto da buttare quello che ha portato. Comunque, per quanto il titolo parli di "coraggio", bisognerà dire che questo resta un grande libro, un classico, sulla paura di guerra, come potrebbe essere, nel caso della Prima guerra mondiale, la novella intitolata proprio La paura di Federico De Roberto (che curiosamente come Crane non fu combattente).
Il libro di Stephen Crane conta ormai diverse traduzioni in italiano, quasi tutte rese con lo stesso titolo (fa eccezione la prima di Bruno Fonzi del 1947: Rosso è l'emblema del coraggio). Vi si sono cimentati in molti insomma, da Giulio Bollati a Gaetano e Giacomo Prampolini, e tra questi si registra anche il caso di Luciano Bianciardi. Non stupisce trovare il nome dello scrittore grossetano tra i traduttori di Crane, considerato il suo interesse per l'Ottocento, per quel periodo storico, per Garibaldi. In questi mesi di ritorno bianciardiano (pensiamo al recente volumone Il cattivo profeta. Romanzi, racconti, saggi e diari pubblicato da Il Saggiatore), la casa editrice SE ripropone nella collana "Assonanze" la traduzione bianciardiana de Il segno rosso del coraggio apparsa per Mondadori nel 1966 e nel 1976 (pp. 160, euro 20, revisione di Luciana Bianciardi). Il libro, che in quanto classico non necessita di troppi cenni alla trama né rischia cedimenti in spoiler pesantemente sanzionati, può rappresentare una lettura diramata su più fronti: al di là dell'eccezionale testimonianza-senza-testimonianza che si trovò a rappresentare questo titolo di Crane, ci troviamo di fronte a uno dei casi di "realismo" di fine Ottocento che più fece discutere. Al centro vi è sia la questione psicologica, sia quella descrittiva e mimetica, come in tutto ciò che riporta a parlare di realismo. Discorsi di gloria, brandelli di eroismo, un'enorme paura, la vergogna e infine il coraggio sono gli stadi sui quali Crane ha dipinto le campate di questo moderno romanzo sulla solitudine di guerra. Immagino si sia già operato in tal senso, ma credo che un raffronto tra l'opera di Crane e la successiva fiumana di scrittura prodotta dalla Prima guerra mondiale possa portare a proficue osservazioni. E la traduzione di Bianciardi, nonostante il mezzo secolo abbondante sulle spalle, non è così invecchiata, anzi. Considerando la velocità alla quale sono invecchiate alcune traduzioni coeve di altri libri, magari anche di autori americani, verrebbe quasi da parlare di un prodigio bianciardiano.
Visualizzazione post con etichetta SE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta SE. Mostra tutti i post
giovedì 16 agosto 2018
venerdì 29 dicembre 2017
"Amedeo Modigliani e altri scritti" di Anna Achmatova
Nella bella collana "Testi e documenti" di SE torna reperibile Amedeo Modigliani e altri scritti di Anna Achmatova (a cura di Eridano Bazzarelli, pp. 176, euro 20), un libro che era finito nel mare dell'irreperibilità. Il volume raduna alcuni scritti della scrittrice russa, tra cui quello che presta il titolo al volume, pagine che segnano anche il passo complessivo della pubblicazione incentrata soprattutto su testimonianze e memoriali brevi. Tuttavia, come vedremo in chiusura, è forse negli scritti lontani dalla memorialistica che Achmatova ha lasciato le pagine più gravide di conseguenze, anche per il lettore di oggi. Come spesso accade con i libri di questo editore, ricca è l'appendice iconografica che si apre con la celebre foto di profilo dell'autrice e si chiude con la foto del suo funerale, nella quale Iosif Brodskij osserva la salma con una mano appoggiata alla guancia. Sarebbe utile aprire una piccola parentesi sui volumi di questa collana, che tanto spesso risultano irrinunciabili quanto ancora più spesso scappano da qualsiasi radar di recensioni, critica o discussione, forse perché slegati da qualsivoglia logica di contingenza, di promozione forzata e di tempi strettissimi che si danno a un libro per sopravvivere. Per certi aspetti non è esagerato vedere certi libri come delle meteore che compaiono e si prendono-acquistano al volo (anche a costo di non leggerli subito) per poi scomparire lesti nel dimenticatoio. Il punto però non è dimenticare i libri o preoccuparsi per i dati ISTAT sulla lettura (per quello che mi riguarda, comprendo benissimo le ragioni di chi dice di non leggere o di non essere interessato alla lettura, tanto quanto capisco e ascolto gli entusiasmi di chi mi consiglia un dato titolo).
Chi avvicinerà questo volume allora troverà il già citato scritto su Modigliani carico d'affetto, i fogli d'album su Mandel'štam, i ricordi di Lozinskij e Aleksandr Blok, una breve nota sui versi di una quasi dimenticata Nadežda L'vova, scritta in occasione della morte precoce della scrittrice di poesie, e ben quattro contributi su Puškin, tra i quali analisi approfondite della Fiaba del galletto d'oro e dell'influenza dell'Adolphe di Benjamin Constant nell'opera dello scrittore russo. Soprattutto quest'ultimo, nel quale la concentrazione critica di Achmatova è massima e il lato memorialistico passa in secondo piano, rappresenta per il lettore d'oggi il momento di maggiore interesse del volume. Il senso di un'espressione accademica come "letterature comparate" acquista qua forza e necessità e si palesa in un nuovo ventaglio di possibilità. Insomma, volendo azzardare un consiglio, si tratta di un libro e soprattutto di un saggio dedicato a tutti i comparatisti. Qui è da ascoltare Bazzarelli che chiude la sua nota definendolo un modello "per cui si può accettare la comparazione come uno dei metodi fondamentali per capire il fatto letterario".
Chi avvicinerà questo volume allora troverà il già citato scritto su Modigliani carico d'affetto, i fogli d'album su Mandel'štam, i ricordi di Lozinskij e Aleksandr Blok, una breve nota sui versi di una quasi dimenticata Nadežda L'vova, scritta in occasione della morte precoce della scrittrice di poesie, e ben quattro contributi su Puškin, tra i quali analisi approfondite della Fiaba del galletto d'oro e dell'influenza dell'Adolphe di Benjamin Constant nell'opera dello scrittore russo. Soprattutto quest'ultimo, nel quale la concentrazione critica di Achmatova è massima e il lato memorialistico passa in secondo piano, rappresenta per il lettore d'oggi il momento di maggiore interesse del volume. Il senso di un'espressione accademica come "letterature comparate" acquista qua forza e necessità e si palesa in un nuovo ventaglio di possibilità. Insomma, volendo azzardare un consiglio, si tratta di un libro e soprattutto di un saggio dedicato a tutti i comparatisti. Qui è da ascoltare Bazzarelli che chiude la sua nota definendolo un modello "per cui si può accettare la comparazione come uno dei metodi fondamentali per capire il fatto letterario".
On parle de:
Amedeo Modigliani,
Amedeo Modigliani e altri scritti,
Anna Achmatova,
SE
sabato 24 giugno 2017
Jisei. Le poesie giapponesi dell'addio a cura di Ornella Civardi
"Poesia di commiato, composta nell'imminenza della morte appositamente perché sia ricordata come l'ultima, e dunque investita di un particolare rilievo. A seconda dello schema metrico e compositivo che utilizza, può essere jisei no ku (se in forma di haiku), jisei no uta (se in forma di tanka), jisei no shi (se in forma di kanshi." Questo ci ricorda l'utile "Glossario" posto in coda al volume Jisei. Poesie dell'addio da poco pubblicato da SE per la cura di Ornella Civardi (pp. 127, euro 14). Si sarebbe portati a ipotizzare sempre chissà cosa per una poesia scritta (dipinta?) in prossimità di uno dei due momenti inaggirabili della vita, il solo dei due, tra altro, in cui l'uomo abbia già fatto una certa conoscenza profonda del linguaggio. In realtà, chi leggerà questi cento componimenti che spaziano dal 900 circa (con il primo di Ono no Komachi) al 1970 (con l'ultimo di un a noi più familiare Mishima Yukio) troverà di tutto, spesso anche l'ironia colta poco prima di ributtarsi nel fiume della natura dal quale il corpo è venuto, poco prima di smettere di essere "soggetto". (Tra parentesi: verrebbe da soffermarsi su questo "soggetto": in Occidente, quanto ci interessa la letteratura come "soggettiva", "confessione", portatrice di una "visione"? Non è una critica all'Occidente, ma solo una constatazione.) E non è una pratica abbandonata quella dei jisei, se anche il regista e sceneggiatore Satoshi Kon ha fatto parlare di sé lasciando il suo jisei quando è morto nel 2010 a 47 anni. Il punto non credo sia acuire la sensibilità - o pensare a una sensibilità acuita - soltanto perché c'è di mezzo quel momento di commiato dalla vita. Se la poesia è legata tanto alla morte quanto alla vita è perché, in qualità di buco ritmico della lingua, rinvia continuamente a entrambe, o per meglio dire è entrambe. Il gesto di scrivere "l'ultima" e riporre il pennello è chiaramente un gesto dell'ambizione, di quell'ambizione stessa che è spesso travisata, ma che resta il motore immobile di ogni esistenza umana (e bisognerebbe provare a discutere a lungo dell'ambizione, io penso).
Editorialmente parlando, con questo libro ritorna il numero 100 per un libro dedicato alla poesia giapponese, come l'indimenticato Cento haiku di Guanda curato da Irene Iarocci e accompagnato da una nota ficcante di Andrea Zanzotto. Ornella Civardi, che ha composto questo percorso in 100 stazioni, ricorda nella sua nota conclusiva che chi avrà la pazienza di scorrere lo sterminato repertorio di jisei potrà scoprire come nel corso dei secoli si sia evoluto il gusto estetico e come queste poesie estreme rivelino l'emergere di mode e filoni letterari, mutamenti della società, della sensibilità e del rapporto con la morte. Tutto ciò si registra in un'alternanza di registri e toni, con un incremento sensibile dei componimenti di donne all'altezza del nono e decimo secolo. L'innesto del buddhismo, che in Giappone penetra verso il sesto secolo, costituirà un flusso fondamentale per lo sviluppo di questa pratica poetica così intima con il sentimento di transitorietà e trascolorazione della vita e pure con un certo languore, atteggiamento che chi frequenta la poesia giapponese, anche in traduzione, ha probabilmente ben presente. Ricorda la curatrice:
Come la luna
che si compone sull'acqua
nella conca delle mani,
questo mondo non sappiamo
se sia o se non sia.
Come ricordato, i motivi e i toni sono tanti, e con un salto al 1781 leggiamo Gessen Zenne che scrive:
Alla sbarra
del giudizio finale
nemmeno provo
a occultare le colpe.
L'estremo
dei miei crimini
sarà assassinare
il Re degli Inferi.
Oppure c'è il sorprendente jisei di Itō Enryō con la sua scimmia, e la traduzione che precisa "chiara" per l'acqua autunnale, dovendo specificare e aggiungere qualcosa che la poesia giapponese non ha bisogno di specificare quando si riferisce a "acque autunnali":
Acqua chiara d'autunno,
per smaltire la scimmia
di questa vita.
Acque diverse infine in questo esempio di Dazai Osamu, autore del bel libro Il sole si spegne (lo trovate nel catalogo Feltrinelli), che per prendere commiato scrive:
Acque opache
dove nemmeno il glicine
specchia più i grappoli,
di questo lago battuto
dalla tempesta.
Anche se scritte appositamente per degli haiku, ritornano in mente le righe che Zanzotto dedicò alla sua frequentazione della poesia giapponese, a quel "non-rumore del senso che si affaccia dentro il nonsenso della natura quasi a volerlo preservare, perché la natura deve ‘abitare’ in esso per restare madre di tutti i sensi”. E ad un livello ulteriore, terminato questo percorso in cento tappe proposto da Ornella Civardi, giunge anche il momento di farci qualche domanda in più sul morire e su come sta cambiando. Perché magari pare di no, ma muta anche il morire (e possiamo accorgercene soltanto finché siamo in vita).
Editorialmente parlando, con questo libro ritorna il numero 100 per un libro dedicato alla poesia giapponese, come l'indimenticato Cento haiku di Guanda curato da Irene Iarocci e accompagnato da una nota ficcante di Andrea Zanzotto. Ornella Civardi, che ha composto questo percorso in 100 stazioni, ricorda nella sua nota conclusiva che chi avrà la pazienza di scorrere lo sterminato repertorio di jisei potrà scoprire come nel corso dei secoli si sia evoluto il gusto estetico e come queste poesie estreme rivelino l'emergere di mode e filoni letterari, mutamenti della società, della sensibilità e del rapporto con la morte. Tutto ciò si registra in un'alternanza di registri e toni, con un incremento sensibile dei componimenti di donne all'altezza del nono e decimo secolo. L'innesto del buddhismo, che in Giappone penetra verso il sesto secolo, costituirà un flusso fondamentale per lo sviluppo di questa pratica poetica così intima con il sentimento di transitorietà e trascolorazione della vita e pure con un certo languore, atteggiamento che chi frequenta la poesia giapponese, anche in traduzione, ha probabilmente ben presente. Ricorda la curatrice:
Mono no aware è letteralmente «il senso delle cose», sostanziato di empatia e nostalgia, che definisce questo sguardo languido di cui è pervasa tutta la letteratura giapponese degli inizi, incardinata sull'idea che solo la consapevolezza dell'impermanenza, e dunque dell'imminenza della perdita, possa liberare l'occhio dal velo opaco indotto dall'abitudine e renderlo finalmente limpido e profondo, capace di svelare la bellezza in tutto il suo fulgore.Il campionario di immagini allora può andare a sovrapporsi con quello che già conosciamo dagli haiku e ci si potrà esercitare a riconoscere il kigo, la parola che colloca la poesia in un dato momento dell'anno, all'interno dei cicli della natura. In questo senso jisei è spesso poesia di commiato dal vedere e dalla vista. Qualche esempio? Ki no Tsurayuki nel 945:
Come la luna
che si compone sull'acqua
nella conca delle mani,
questo mondo non sappiamo
se sia o se non sia.
Come ricordato, i motivi e i toni sono tanti, e con un salto al 1781 leggiamo Gessen Zenne che scrive:
Alla sbarra
del giudizio finale
nemmeno provo
a occultare le colpe.
L'estremo
dei miei crimini
sarà assassinare
il Re degli Inferi.
Oppure c'è il sorprendente jisei di Itō Enryō con la sua scimmia, e la traduzione che precisa "chiara" per l'acqua autunnale, dovendo specificare e aggiungere qualcosa che la poesia giapponese non ha bisogno di specificare quando si riferisce a "acque autunnali":
Acqua chiara d'autunno,
per smaltire la scimmia
di questa vita.
Acque diverse infine in questo esempio di Dazai Osamu, autore del bel libro Il sole si spegne (lo trovate nel catalogo Feltrinelli), che per prendere commiato scrive:
Acque opache
dove nemmeno il glicine
specchia più i grappoli,
di questo lago battuto
dalla tempesta.
Anche se scritte appositamente per degli haiku, ritornano in mente le righe che Zanzotto dedicò alla sua frequentazione della poesia giapponese, a quel "non-rumore del senso che si affaccia dentro il nonsenso della natura quasi a volerlo preservare, perché la natura deve ‘abitare’ in esso per restare madre di tutti i sensi”. E ad un livello ulteriore, terminato questo percorso in cento tappe proposto da Ornella Civardi, giunge anche il momento di farci qualche domanda in più sul morire e su come sta cambiando. Perché magari pare di no, ma muta anche il morire (e possiamo accorgercene soltanto finché siamo in vita).
On parle de:
Andrea Zanzotto,
Dazai Osamu,
Gessen Zenne,
Irene Iarocci,
Itō Enryō,
Jisei. Poesie dell'addio,
Ornella Civardi,
Satoshi Kon,
SE
domenica 12 febbraio 2017
"Chiari del bosco" di María Zambrano ritorna disponibile per SE
Riletture di classici o quasi classici (dentro o fuori catalogo) #34
Da qualche anno non era più agevole per il lettore italiano procurarsi Chiari del bosco di María Zambrano. A rimettere in circolo quello che è un libro assai noto della filosofa spagnola allieva di José Ortega y Gasset è SE, che ripropone in un nuovo volume (pp. 155, euro 20) il testo curato a suo tempo da Carlo Ferrucci per un'edizione Bruno Mondadori. A ben vedere questo titolo, uno dei suoi più citati, ha una curiosa storia ondivaga tra case editrici italiane, se pensiamo che la stessa edizione di cui parliamo oggi aveva trovato posto inizialmente nel catalogo di Feltrinelli nel 1991. Siamo quindi già a quota tre editori diversi che, nel giro di un quarto di secolo, hanno messo in circolazione la traduzione di un'opera di una scrittrice-filosofa che non smette di frequentare con una certa costanza gli scaffali delle librerie italiane (penso anche al recente L'esilio come patria pubblicato da Morcelliana). Si verificano proprio nella scrittura e nel "pensiero del pensiero" (così come nel suo controllo o abbandono) movimento e scotimento per chi legge. In questi paragrafi - cosa non frequentissima, almeno per quel che percepisco da fruitore di alcuni libri degli scaffali di filosofia - la pratica della filosofia coincide con una voce collocata in uno spazio di conversazione, accompagnamento e "guida", in un luogo della mente in cui il "rispetto" per il famigerato lettore è davvero massimo, quasi distillato a ogni passo. Si legge nello scritto di Carlo Ferrucci che le caratteristiche di Chiari del bosco
Claros del bosque compie nel 2017 quarant'anni e continua a essere una lettura inevitabile tra quelle che ci propone il curpus dei testi mistici europei, lampeggia ancora come una radura avvicinabile, con pagine in cui filosofia razionalistica, mistica, mitologia e poesia si sono compenetrate, dove la scrittura è a uno stadio ninfale che precede una metamorfosi che potrà accadere solo tra le mani di un lettore. Il migliore invito alla lettura di un libro così è riportarne almeno l'incipit, poi, sul come leggere questo passo e queste pagine, verrà chiamata a raccolta l'intelligenza di ognuno, attraverso sentieri che non necessariamente si riveleranno interrotti.
Da qualche anno non era più agevole per il lettore italiano procurarsi Chiari del bosco di María Zambrano. A rimettere in circolo quello che è un libro assai noto della filosofa spagnola allieva di José Ortega y Gasset è SE, che ripropone in un nuovo volume (pp. 155, euro 20) il testo curato a suo tempo da Carlo Ferrucci per un'edizione Bruno Mondadori. A ben vedere questo titolo, uno dei suoi più citati, ha una curiosa storia ondivaga tra case editrici italiane, se pensiamo che la stessa edizione di cui parliamo oggi aveva trovato posto inizialmente nel catalogo di Feltrinelli nel 1991. Siamo quindi già a quota tre editori diversi che, nel giro di un quarto di secolo, hanno messo in circolazione la traduzione di un'opera di una scrittrice-filosofa che non smette di frequentare con una certa costanza gli scaffali delle librerie italiane (penso anche al recente L'esilio come patria pubblicato da Morcelliana). Si verificano proprio nella scrittura e nel "pensiero del pensiero" (così come nel suo controllo o abbandono) movimento e scotimento per chi legge. In questi paragrafi - cosa non frequentissima, almeno per quel che percepisco da fruitore di alcuni libri degli scaffali di filosofia - la pratica della filosofia coincide con una voce collocata in uno spazio di conversazione, accompagnamento e "guida", in un luogo della mente in cui il "rispetto" per il famigerato lettore è davvero massimo, quasi distillato a ogni passo. Si legge nello scritto di Carlo Ferrucci che le caratteristiche di Chiari del bosco
corrispondono a quelle della 'guida', un genere di testo passato in Spagna dall'Oriente, che è composto di figure alimentate dalla fantasia piuttosto che da argomentazioni, che è insieme comunicativo ed enigmatico, che suggerisce più di quanto non dica perché vuole che le sue verità rinascano e rivivano il più direttamente possibile nell'interiorità del lettore. Questi viene condotto, così, non tanto a condividere un sapere, quanto ad assimilare un'esperienza di tipo iniziatico, alimentata da una scrittura fortemente ellittica, lampeggiante, ora fin troppo coordinata ora bruscamente scoordinata, che lo obbliga a farsene coautore, a esporsi con tutto se stesso azzardando significati che il testo non garantisce. E che confluiscono in un 'logos sommerso' o 'logos del pathos', come la Zambrano ha chiamato in un'altra opera questa forma di comprensione inseparabile dalla situazione vitale di quanti si trovano a parteciparne.Che cosa significa pensare? In quanti modi pensiamo? Cosa accade nel e per il pensiero? C'è un modo cartesiano di affrontare simili questioni. Poi c'è anche un versante che, provando a condurre alla cima di queste terribili e sublimi domande, riconduce alla mistica e alla poesia: è questa parte della montagna che percorriamo leggendo più opere di María Zambrano. Il lettore prenda a esempio paragrafi come "Solo la parola" o "Lo sguardo remoto". A me pare che buona parte dell'innovazione portata da María Zambrano avvenga dentro la scrittura e per questo, poco sopra, ho voluto usare l'espressione "scrittrice-filosofa". María Zambrano è anche una scrittrice di "ellissi" e usa la reticenza come una lama affilatissima.
Di qui il riecheggiare, in queste pagine, della visione sapienziale dei presocratici, delle religioni salvifiche greche e romane, della tradizione gnostica, dell'idea - mutuata tra l'altro da Nietzsche - della filosofia come 'trasformazione'.
Claros del bosque compie nel 2017 quarant'anni e continua a essere una lettura inevitabile tra quelle che ci propone il curpus dei testi mistici europei, lampeggia ancora come una radura avvicinabile, con pagine in cui filosofia razionalistica, mistica, mitologia e poesia si sono compenetrate, dove la scrittura è a uno stadio ninfale che precede una metamorfosi che potrà accadere solo tra le mani di un lettore. Il migliore invito alla lettura di un libro così è riportarne almeno l'incipit, poi, sul come leggere questo passo e queste pagine, verrà chiamata a raccolta l'intelligenza di ognuno, attraverso sentieri che non necessariamente si riveleranno interrotti.
Il chiaro del bosco è un centro nel quale non sempre è possibile entrare; lo si osserva dal limite e la comparsa di alcune impronte di animali non aiuta a compiere tale passo. È un altro regno che un’anima abita e custodisce. Qualche uccello richiama l’attenzione, invitando ad avanzare fin dove indica la sua voce. E le si dà ascolto. Poi non si incontra nulla, nulla che non sia un luogo intatto che sembra essersi aperto solo in quell’istante e che mai più si darà così. Non bisogna cercarlo. Non bisogna cercare. È la lezione immediata dei chiari del bosco: non bisogna andare a cercarli, e nemmeno a cercare nulla da loro. Nulla di determinato, di prefigurato, di risaputo. E l’analogia del chiaro con il tempio può sviare l’attenzione [...] E resta il nulla e il vuoto che il chiaro del bosco dà in risposta a quello che si cerca. Mentre se non si cerca nulla l’offerta sarà imprevedibile, illimitata. Giacché sembra che il nulla e il vuoto - o il nulla o il vuoto - debbano essere presenti o latenti di continuo nella vita umana. E che per non essere divorato dal nulla o dal vuoto uno debba farli in se stesso, debba almeno trattenersi, rimanere in sospeso, nel negativo dell’estasi. Sospendere la domanda che crediamo costitutiva dell’umano. La funesta domanda alla guida, alla presenza che si dilegua se la si incalza, alla propria anima asfissiata dal domandare della coscienza insorgente, alla propria mente cui non si lascia il tempo di concepire silenziosamente, oscuramente anche, senza che quella si interponga per domandare il rendiconto alla schiava ammutolita. E il timore dell’estasi che assale al cospetto della chiarezza vivente fa fuggire dal chiaro del bosco il suo visitatore, che diventa così un intruso.
On parle de:
Bruno Mondodari,
Carlo Ferrucci,
Chiari del bosco,
Feltrinelli,
José Ortega y Gasset,
María Zambrano,
Riletture,
SE
mercoledì 16 novembre 2016
Il manuale di Epitteto tradotto da Giacomo Leopardi (e qualche nota editoriale)
Riletture di classici o quasi classici (dentro o fuori catalogo) #33
Covertures #13
Il Manuale di Epitteto, redatto in realtà dall'allievo Arriano di Nicomedia, ebbe a partire dal Cinquecento rinnovata fortuna fino ai giorni nostri e prova ne siano le diverse edizioni in commercio, qua rappresentate anche dalle loro copertine (manca l'edizione della collana Piccola Biblioteca Einaudi curata da Pierre Hadot e quella di Garzanti dei Grandi Libri). Quando il manuale, nell'autunno del 1825, incontrò l'intento traduttorio di Giacomo Leopardi durante il suo soggiorno bolognese, non era insomma opera dimenticata e il lettore colto poteva disporre di una manciata di traduzioni e pure della versione latina curata da Angelo Poliziano (sia detto per inciso che l'edizione Garzanti del Manuale propone sia il testo leopardiano che la versione latina del Poliziano). Leopardi, che con l'editore milanese Stella stava provando a progettare in quel tempo una serie di libri dal formato contenuto che proponessero le principali opere dei moralisti greci e altre iniziative editoriali che dovevano, almeno negli intenti, contribuire al suo mantenimento economico, lavorò sul testo greco per un paio settimane e consegnò il manoscritto della traduzione all'editore senza tenere copia per sé. Non vide mai pubblicata l'opera, che fu stampata soltanto dopo la sua morte nell'edizione delle opere curata dal Ranieri. Si tratta di una traduzione che tenne per sempre molto cara e che a più riprese provò a far pubblicare senza successo. Il periodo bolognese-milanese del poeta coincideva con l'inizio della stesura della sua opera capitale, le Operette morali, le quali videro la prima edizione non lontana dalla ventisettana de I promessi sposi e quindi varie edizioni successive.
Dopo il "Preambolo del volgarizzatore", laddove Leopardi riduce la dimensione eroica dei potenziali destinatari dell'opera, così attacca la traduzione del Manuale del filosofo stoico Epitteto:
Molto interessante è quindi lo studio di Leopardi anche alla luce dei suoi rapporti editoriali mentre era in vita, così come spesso è interessante compiere simile analisi con altri autori (si è già parlato in termini analoghi per Manganelli). Oggi non abbiamo bisogno di sforzarci per trovare la sua traduzione da Epitteto, che potete scaricare come PDF qui, oppure acquistare nei volumi rappresentati in foto (dall'alto: Salerno editrice, SE, Bur e a voi giudicare le copertine più riuscite e quella davvero fuori centro...). Ci si è chiesti se la sua versione deviasse in qualche modo l'interpretazione "giusta" di questo classico collocato in un'epoca di apparente fine della filosofia, eppure i precetti di Epitteto raccolti da Arriano e tradotti, fra molti altri, anche da Giacomo Leopardi stanno lì a raccontarci anche dell'incalcolabile destino dei libri e dei classici. Per ricordare un'altra celebre versione, il Manuale fu tradotto anche dal gesuita Matteo Ricci come libro di mediazione (più che di meditazione) nel proprio viaggio cinese e titolato Il libro dei 25 paragrafi. Sono tanti oggi i libri sulla saggezza, sui precetti, sulla sapienza, quasi un genere editoriale a sé in grado di attrarre lettori anagraficamente diversi. Eppure in questo "libricciuolo" contenente i precetti di Epitteto possiamo riscontrare un andirivieni del destino che ci parla da vicino dei classici, del loro essere tutt'altro che libri immutabili e dati una volta per tutte. Il lascito di Leopardi allora sta anche nell'intendere questa non immutabilità del classico che ha goduto di molta fortuna.
Covertures #13
Il Manuale di Epitteto, redatto in realtà dall'allievo Arriano di Nicomedia, ebbe a partire dal Cinquecento rinnovata fortuna fino ai giorni nostri e prova ne siano le diverse edizioni in commercio, qua rappresentate anche dalle loro copertine (manca l'edizione della collana Piccola Biblioteca Einaudi curata da Pierre Hadot e quella di Garzanti dei Grandi Libri). Quando il manuale, nell'autunno del 1825, incontrò l'intento traduttorio di Giacomo Leopardi durante il suo soggiorno bolognese, non era insomma opera dimenticata e il lettore colto poteva disporre di una manciata di traduzioni e pure della versione latina curata da Angelo Poliziano (sia detto per inciso che l'edizione Garzanti del Manuale propone sia il testo leopardiano che la versione latina del Poliziano). Leopardi, che con l'editore milanese Stella stava provando a progettare in quel tempo una serie di libri dal formato contenuto che proponessero le principali opere dei moralisti greci e altre iniziative editoriali che dovevano, almeno negli intenti, contribuire al suo mantenimento economico, lavorò sul testo greco per un paio settimane e consegnò il manoscritto della traduzione all'editore senza tenere copia per sé. Non vide mai pubblicata l'opera, che fu stampata soltanto dopo la sua morte nell'edizione delle opere curata dal Ranieri. Si tratta di una traduzione che tenne per sempre molto cara e che a più riprese provò a far pubblicare senza successo. Il periodo bolognese-milanese del poeta coincideva con l'inizio della stesura della sua opera capitale, le Operette morali, le quali videro la prima edizione non lontana dalla ventisettana de I promessi sposi e quindi varie edizioni successive.
Dopo il "Preambolo del volgarizzatore", laddove Leopardi riduce la dimensione eroica dei potenziali destinatari dell'opera, così attacca la traduzione del Manuale del filosofo stoico Epitteto:
Le cose sono di due maniere; alcune in potere nostro, altre no. Sono in potere nostro la opinione, il movimento dell'animo, l'appetizione, l'aversione, in breve tutte quelle cose che sono nostri propri atti. Non sono in poter nostro il corpo, gli averi, la riputazione, i magistrati, e in breve quelle cose che non sono nostri propri atti.Si tratta di una distinzione fondamentale, su cui è ancorato tutto il resto del discorso dello stoico. Quel che interessa oggi, al di là di tutti i ragionamenti che leopardisti, critici illustri e divulgatori hanno già prodotto, è un grumo di riflessioni che si possono fare e che partono e arrivano a questo Manuale: si può affermare che Leopardi è autore di una prima versione in italiano moderno del "libricciuolo", lo traduce in appena un paio di settimane in un momento centrale della propria riflessione filosofica, non ne violenta la natura e non trasforma Epitteto in uno dei propri precursori rifacendosi, in qualche modo, alla massima che ogni autore "crea" i propri precursori; sarebbe troppo limitante traslare questa massima anche in terreno leopardiano, tanto imponente è infatti l'arcata di ponte che Leopardi getta tra due epoche. (In realtà, sulla chiave di lettura "attualizzante" del Manuale fornita dal recanatese il dibattito non è unanime, mentre è quasi unanime l'apprezzamento della lingua scelta da Leopardi per la traduzione.) Inoltre, cosa non da poco, Giacomo Leopardi cala in Epitteto, in quattro operette morali di Isocrate e in altre traduzioni soltanto ipotizzate un progetto editoriale che mai vide la luce e che tuttavia sarebbe interessante provare a ripercorrere e ricostruire. Molte sono le ragioni per cui tutto naufragò e non ultima va considerata l'urticante scomodità politica del pensiero leopardiano. Tuttavia ci sono le premesse per poter parlare o tornare a parlare anche di un certo pensiero pratico-editoriale di Leopardi o, se non altro, di un suo rapporto con l'atto del pubblicare (verbo che oggi assume connotati sempre cangianti). Anche quando consegna al mondo la propria opera più sconvolgente camuffata dal diminutivo del titolo, le Operette morali, viene da chiedersi se Leopardi riponga nel meccanismo dialogico, così preponderante in questo libro, la possibilità di aggirare certi meccanismi censorei che difficilmente forse avrebbe superato.
Le cose poste in nostro potere sono di natura libere, non possono essere impedite né attraversate. Quelle altre sono deboli, schiave, sottoposte a ricevere impedimento, e per ultimo sono cose altrui.
Molto interessante è quindi lo studio di Leopardi anche alla luce dei suoi rapporti editoriali mentre era in vita, così come spesso è interessante compiere simile analisi con altri autori (si è già parlato in termini analoghi per Manganelli). Oggi non abbiamo bisogno di sforzarci per trovare la sua traduzione da Epitteto, che potete scaricare come PDF qui, oppure acquistare nei volumi rappresentati in foto (dall'alto: Salerno editrice, SE, Bur e a voi giudicare le copertine più riuscite e quella davvero fuori centro...). Ci si è chiesti se la sua versione deviasse in qualche modo l'interpretazione "giusta" di questo classico collocato in un'epoca di apparente fine della filosofia, eppure i precetti di Epitteto raccolti da Arriano e tradotti, fra molti altri, anche da Giacomo Leopardi stanno lì a raccontarci anche dell'incalcolabile destino dei libri e dei classici. Per ricordare un'altra celebre versione, il Manuale fu tradotto anche dal gesuita Matteo Ricci come libro di mediazione (più che di meditazione) nel proprio viaggio cinese e titolato Il libro dei 25 paragrafi. Sono tanti oggi i libri sulla saggezza, sui precetti, sulla sapienza, quasi un genere editoriale a sé in grado di attrarre lettori anagraficamente diversi. Eppure in questo "libricciuolo" contenente i precetti di Epitteto possiamo riscontrare un andirivieni del destino che ci parla da vicino dei classici, del loro essere tutt'altro che libri immutabili e dati una volta per tutte. Il lascito di Leopardi allora sta anche nell'intendere questa non immutabilità del classico che ha goduto di molta fortuna.
Sovvengati che tu non sei qui altro che attore di un dramma, il quale sarà o breve o lungo, secondo la volontà del poeta. E se a costui piace che tu rappresenti la persona di un mendico, studia di rappresentarla acconciamente. Il simile se ti è assegnata la persona di un zoppo, di un magistrato, di un uomo comune. Atteso che a te si aspetta solamente di rappresentar bene quella qual si sia persona che ti è destinata: lo eleggerla si appartiene a un altro.Anche in un passo come questo sopra riportato - siamo nel secondo secolo dopo Cristo - si nota l'inversione di una concezione radicata: il teatro che passa da mimesi della vita a paradigma della conoscenza. Si tratta di uno dei tanti motivi di interesse per l'Enchiridion di questo ennesimo schiavo frigio a cui dobbiamo molto (un altro era Esopo). Oggi, se dovessi indicare una direzione su cui questo testo è più che mai attivo, indicherei la questione del narcisismo; anche quell'incipit sopra riportato spedisce diritto a una quantomai opportuna distinzione tra io e non-io e a una feconda delimitazione della prima persona, soprattutto in senso morale. In questo riesce il Manuale, pur non accennando ad alcuna divinità e in questo riesce anche il ridimensionamento eroico del Leopardi-editore:
Io per verità sono di opinione che la pratica filosofica che qui s'insegna, sia, se non sola tra le altre, almeno più delle altre profittevole nell'uso della vita umana, più accomodata all'uomo, e specialmente agli animi di natura o d'abito non eroici, né molto forti, ma temperati e forniti di mediocre fortezza, o vero eziandio deboli, e però agli uomini moderni ancora più che agli antichi. (dal "Preambolo del volgarizzatore")
martedì 3 maggio 2016
"Oscillazioni. Frammenti di un'autobiografia" di Federico Ferrari: "Questo sei tu. Io sono già altrove."
L'aforisma è un fuoco fatuo, lo aveva colto già Camillo Sbarbaro e lo rammenta Federico Ferrari in questo suo libro intitolato Oscillazioni. Frammenti di un'autobiografia pubblicato pochi giorni fa da SE (pp. 112, euro 18). Abbiamo davanti un volume di aforismi e apoftegmi che raramente ci capita di poter leggere, non so se a causa della non eccelsa fortuna del genere nel nostro paese (d'accordo, Leopardi e Flaiano figurano tra queste pagine e non solo nel risvolto di copertina) o a causa di quel fraintendimento - ontologico ma anche editoriale - nel quale qualsiasi precipitato autobiografico è stato aspirato. Un'oscillazione è solitamente intesa come il moto di un corpo tra due estremità ed è pure un termine con cui ci si riferisce al variare di una grandezza. Si dice anche oscillazione di una sorta di indecisione della lingua attorno a un vocabolo, alla sua grafia, ad esempio. Questo libro di frammenti che inevitabilmente vanno a fondare l'auto-bio-grafia di cui dice il titolo, e nel quale gli spazi tra un frammento e l'altro sono il ritmo del pensiero - oscillazione, onda, periodo sono tutte immagini che si inseguono - offre una possibilità rara di confronto con il pensiero e la sua essenza del tutto misteriosa. Ed è il pensiero stesso, nella sua "potenza anonima" (avvicinabile forse a una potenza parimenti anonima dell'eros?), a interessare queste vibrazioni di frasi, sia esso preso dallo spigolo della psicanalisi (per la quale Ferrari ha aspre parole), del trauma originario ("mitologia di bassa lega: risciacquo teologico"), dell'arte, della filosofia (Eraclito, soprattutto Plotino e poco Cioran), delle neuroscienze o dell'esperienza, la quale lascia tracce "assai superficiali rispetto alle cicatrici di cui è capace la parola". Per le cronache e per gli interessati: Federico Ferrari insegna filosofia dell'arte e fenomenologia delle arti contemporanee all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ne ha anche per il mondo universitario-accademico e sarà facile, per chi ha avuto una qualche esperienza di università negli ultimi vent'anni, convenire amaramente (taluni grandi filosofi si sono interrogati sul destino delle università, possibile che questo destino non interessi più?). Ad ogni modo, stavolta davvero non hanno importanza la provenienza e il curriculum di chi ha scritto questi righi e ritmi, e conta invece la proposta complessiva dell'opera, il suo saper far risplendere di inizi e albe i temi più disparati, siano questi le epoche, la nostalgia del futuro, la scrittura a quattro mani collegata alla potenza anonima del pensiero di cui sopra o la "superbia dell'autore", i nomi propri contrapposti al "senza nome" e all'indistinto, fonte di estasi e, assieme al pensiero, secondo capo della fune tesa dove oscilla la corda del funambolo (come quello di Klee scelto per la copertina). Oppure c'è la solitudine, la quale "non è un sentimento triste" ("Amare un essere umano significa far precipitare la propria solitudine dentro quella di un altro [...]"). Che cosa sono questi aforismi? Circa a metà dell'opera leggiamo: "Il frammento è sempre un inizio assoluto. Tutto quello che è venuto prima è dimenticato (e da dimenticare)".
 |
| Francisco Goya, Vuelo de brujas (1798) |
Come invito a cercare e leggere queste pagine ripercorro allora alcuni frammenti dell'opera, le sue oscillazioni, che possono sfiorare i mistici (i veri atei), la conoscenza come inizio del disincanto e di una melanconia infinita, il vedere che non è leggere (in questi passaggi l'infilarsi nella nostra più trita quotidianità è acuto), il "fine della lettura" inteso come l'istante in cui si alzano gli occhi dalla pagina, l'aristocratico e la democrazia, l'orgasmo e la masturbazione, il buon gusto come questione di attenzione, lo scrivere inteso come gesto che dà dignità al mondo, lo squallore del mercato editoriale davanti al quale non restano che "edizioni semiclandestine e incontri inattesi", l'ingenuità degli intellettuali e la mancanza di gusto tra gli uomini di cultura, considerazioni sul numero dei lettori e sul "successo", la grazia dell'esistenza che solo chi è stato abbandonato almeno una volta può comprendere o l'autosufficienza di ogni epoca ("Non ci sono epoche migliori di altre. In ogni epoca c'è tutto: genio, finezza, grandezza, volgarità e decadenza."). Gli si crede quando scrive "Un piccolo quadro di Goya, Vuelo de brujas, vale per me più di tutta l'arte contemporanea". Insomma, questa mia campionatura profondamente stupida, perché annienta il ritmo della scrittura e le oscillazioni del pensiero, i suoi bianchi e le sue esitazioni, valga almeno come invito a verificare questa scrittura e saggiarne la suddivisione del tempo, la frequentazione del mistero del pensiero e dell'indistinto. Un invito a leggere che ho sparso in queste righe, qui e ora ("Qui e ora, cioè altrove.")
giovedì 4 febbraio 2016
"Giorni e opere" di Stefan George
Quote #10
"To repeat or copy the words of another, usually with acknowledgment of the source." Questo il verbo "to quote". Ma in italiano "quote" è il plurale di quota, parola che mi interessa soprattutto nel senso della misura di un'altezza o di un lato. Citando e contestualizzando minimamente passi importanti, cerco un modo assai svelto di dar notizia di libri significativi, possibilmente brevi. Stando breve, pure io.
Uscì nel 1903 Tage und Taten. Aufzeichnungen und Skizzen, unica opera in prosa del poeta tedesco Stefan George (1868 - 1933). Qualche mese fa il testo è stato finalmente proposto in italiano da SE per la cura di Giulio Schiavoni (pp. 118, euro 19, con apparato iconografico comprendente tavole di Cimabue, Quentin Metsys, Dierick Bouts, Arnold Böcklin, Max Klinger). Questo libro che inverte gli elementi del titolo dell'opera esiodea ha più di un motivo per imporsi alla nostra attenzione: la singolarità di essere l'unica opera in prosa di George, il collocarsi a metà del suo percorso, negli anni in cui il poeta smise, almeno per un po', uno stile di vita girovago per abitare più stabilmente a Monaco di Baviera, il periodo di avvicinamento all'efebo Maximin (che di lì a poco morì, a soli 18 anni). Insomma, è un libro che assomiglia da vicino a uno spartiacque, anche per la poesia - e quindi per il pensiero - che verrà. Si tratta di un insieme di annotazioni e abbozzi, così come recita il sottotitolo dell'originale, che consente a George una ripresa di possesso della materia vitale, eludendo provvisoriamente il percussivo problema della "forma", rimasto sempre inchiodato centralmente nella sua riflessione poetica.
Oggigiorno non è del tutto errato parlare della marginalità di questo poeta che tradusse Dante in tedesco, ma sarebbe un errore invece far coincidere questa marginalità con la marginalità più larga in cui vediamo riversare la poesia. George fu una figura di poeta controversa e di enorme influenza (si pensi al George-Kreis e a chi vi transitò), fu fondamentale nella formazione di Benjamin, Brecht, Buber, Rosenzweig e pure Zweig. Sappiamo che Heidegger si confrontò con lui nelle passeggiate sul linguaggio, ma la sua opera fu anche letta "da sinistra" da Adorno e Lukàcs; infine in qualche modo fu persino corteggiato dal Reich nascente, al quale rispose con un rifiuto e conseguente esilio nell'anno della sua morte. Cinque anni prima di morire, nel 1928, aveva pubblicato un libro che già dal titolo (Das neue Reich; "Il nuovo regno") auspicava un rinnovamento del "regno" che andava in una direzione totalmente opposta a quella del "terzo regno" e undici anni dopo la sua morte, nel 1944, i sodali fratelli von Stauffenberg furono protagonisti della resistenza e dell'attentato contro Hitler. Ora la riconsiderazione dell'opera di Stefan George va di pari passo con quella, altrettanto importante, dell'andamento essenziale da tenere per ripercorrere il ritmo di marcia dei primi decenni del secolo scorso, in prospettiva della conquista di uno studio meno evenemenziale della storia letteraria e della storia delle idee. Il passo che riporto di seguito fornisce un lampo sul senso di quest'unica opera di prosa finalmente disponibile italiano.
IL LAGO MORTO
Tutta la regione, su cui si estende un cielo basso e oscurato, è coperta di miseri sterpi tutti bruciacchiati, che per di più in vaste zone non crescon neppure. Alcune informi pietre nude disposte in tutti i possibili sensi accennano un viottolo che sembra non volere più finire. Poi tutt'a un tratto ecco spuntare, in mezzo a quel deserto, una collinetta piatta avvolta dalla nebbia e sul cui bordo sta un palo tutto disfatto che reca un cartello indicatore. Su quella collina deve trovarsi il lago morto, che sicuramente è nero e denso; e proprio di lì viene quell'odor di bruciato che s'avverte tutt'intorno. Uno dei miei piedi vorrebbe salire, ma l'altro è trattenuto, da un doloroso terrore, dallo spingersi oltre quel palo.
A questo link potete vedere una foto del 1924 dove George, come nella copertina del libro, è ritratto di profilo. Il poeta è in compagnia dei giovani fratelli Von Stauffenberg. Sempre allo stesso link potete ascoltare la registrazione di una lezione del prof. Adone Brandalise in cui si parla, fra gli altri, del nostro poeta.
"To repeat or copy the words of another, usually with acknowledgment of the source." Questo il verbo "to quote". Ma in italiano "quote" è il plurale di quota, parola che mi interessa soprattutto nel senso della misura di un'altezza o di un lato. Citando e contestualizzando minimamente passi importanti, cerco un modo assai svelto di dar notizia di libri significativi, possibilmente brevi. Stando breve, pure io.
Uscì nel 1903 Tage und Taten. Aufzeichnungen und Skizzen, unica opera in prosa del poeta tedesco Stefan George (1868 - 1933). Qualche mese fa il testo è stato finalmente proposto in italiano da SE per la cura di Giulio Schiavoni (pp. 118, euro 19, con apparato iconografico comprendente tavole di Cimabue, Quentin Metsys, Dierick Bouts, Arnold Böcklin, Max Klinger). Questo libro che inverte gli elementi del titolo dell'opera esiodea ha più di un motivo per imporsi alla nostra attenzione: la singolarità di essere l'unica opera in prosa di George, il collocarsi a metà del suo percorso, negli anni in cui il poeta smise, almeno per un po', uno stile di vita girovago per abitare più stabilmente a Monaco di Baviera, il periodo di avvicinamento all'efebo Maximin (che di lì a poco morì, a soli 18 anni). Insomma, è un libro che assomiglia da vicino a uno spartiacque, anche per la poesia - e quindi per il pensiero - che verrà. Si tratta di un insieme di annotazioni e abbozzi, così come recita il sottotitolo dell'originale, che consente a George una ripresa di possesso della materia vitale, eludendo provvisoriamente il percussivo problema della "forma", rimasto sempre inchiodato centralmente nella sua riflessione poetica.
Oggigiorno non è del tutto errato parlare della marginalità di questo poeta che tradusse Dante in tedesco, ma sarebbe un errore invece far coincidere questa marginalità con la marginalità più larga in cui vediamo riversare la poesia. George fu una figura di poeta controversa e di enorme influenza (si pensi al George-Kreis e a chi vi transitò), fu fondamentale nella formazione di Benjamin, Brecht, Buber, Rosenzweig e pure Zweig. Sappiamo che Heidegger si confrontò con lui nelle passeggiate sul linguaggio, ma la sua opera fu anche letta "da sinistra" da Adorno e Lukàcs; infine in qualche modo fu persino corteggiato dal Reich nascente, al quale rispose con un rifiuto e conseguente esilio nell'anno della sua morte. Cinque anni prima di morire, nel 1928, aveva pubblicato un libro che già dal titolo (Das neue Reich; "Il nuovo regno") auspicava un rinnovamento del "regno" che andava in una direzione totalmente opposta a quella del "terzo regno" e undici anni dopo la sua morte, nel 1944, i sodali fratelli von Stauffenberg furono protagonisti della resistenza e dell'attentato contro Hitler. Ora la riconsiderazione dell'opera di Stefan George va di pari passo con quella, altrettanto importante, dell'andamento essenziale da tenere per ripercorrere il ritmo di marcia dei primi decenni del secolo scorso, in prospettiva della conquista di uno studio meno evenemenziale della storia letteraria e della storia delle idee. Il passo che riporto di seguito fornisce un lampo sul senso di quest'unica opera di prosa finalmente disponibile italiano.
IL LAGO MORTO
Tutta la regione, su cui si estende un cielo basso e oscurato, è coperta di miseri sterpi tutti bruciacchiati, che per di più in vaste zone non crescon neppure. Alcune informi pietre nude disposte in tutti i possibili sensi accennano un viottolo che sembra non volere più finire. Poi tutt'a un tratto ecco spuntare, in mezzo a quel deserto, una collinetta piatta avvolta dalla nebbia e sul cui bordo sta un palo tutto disfatto che reca un cartello indicatore. Su quella collina deve trovarsi il lago morto, che sicuramente è nero e denso; e proprio di lì viene quell'odor di bruciato che s'avverte tutt'intorno. Uno dei miei piedi vorrebbe salire, ma l'altro è trattenuto, da un doloroso terrore, dallo spingersi oltre quel palo.
A questo link potete vedere una foto del 1924 dove George, come nella copertina del libro, è ritratto di profilo. Il poeta è in compagnia dei giovani fratelli Von Stauffenberg. Sempre allo stesso link potete ascoltare la registrazione di una lezione del prof. Adone Brandalise in cui si parla, fra gli altri, del nostro poeta.
Iscriviti a:
Post (Atom)