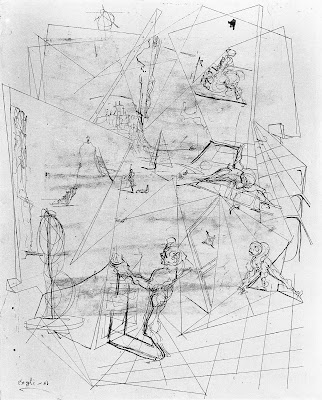Pubblico di seguito uno scritto su Charles Perrault di Ludovico Setten, che ringrazio. Di Ludovico Setten si può leggere anche questo articolo su La mela nel buio di Clarice Lispector apparso su "Librobreve" lo scorso anno.
L’opera
di Charles Perrault si presenta in opposizione al Classicismo del 17° secolo,
che trova la sua espressione, in modo generale, nella poetica e nel pensiero di
Nicolas Boileau. L’autore combatte fieramente e ostinatamente contro la
concezione di superiorità dell’Epoca degli Antichi sull’Epoca di Luigi XIV e
difende la creazione artistica di forme considerate nuove come, ad esempio, il conte des fées, genere letterario che lo
renderà celebre.
La
sua battaglia letteraria comincia nel 1687, quando presenta a l’Académie
Française, di cui era cancelliere, il componimento “Il secolo di Luigi il
Grande”, in cui non solamente egli diminuisce l’importanza dell’Antichità, ma
afferma la superiorità artistica, scientifica e morale dell’epoca del Re Sole,
affermazione che sarà ripresa e approfondita dall’autore nei quattro volumi del
Parallelo degli Antichi e dei Moderni,
in cui uno dei punti principali a favore dell’epoca di Luigi XIV è l’originalità,
strettamente legata all’idea di novità.
La bella
Antichità fu sempre venerabile,
ma non
credetti mai che fosse adorabile.
Vedo gli
Antichi senza piegare le ginocchia,
sono grandi, è
vero, ma uomini come noi;
e si può
comparare senza temere d’essere ingiusto,
il secolo di
LUIGI al bel secolo d’Augusto.
[…]
Se noi
volessimo togliere il velo specioso,
che la
prevenzione ci mette davanti agli occhi,
e, stanchi
d’applaudire a mille errori grossolani,
servirci
qualche volta dei nostri lumi,
vedremmo
chiaramente che, senza temerarietà,
non si può
adorare tutta l’Antichità;
e ch’infine,
ai nostri giorni, senza troppa confidenza,
le si può
disputare il premio della scienza.
Perrault,
pur riconoscendo la grandezza dell’Antichità, invita i suoi contemporanei a
guardare gli autori antichi con occhio critico e attento; egli propone di
formare un giudizio che non sia preventivo e di utilizzare la ragione, “i
nostri lumi”, per affermare la validità di un certo autore o di una certa
opera; infine, egli mette in discussione qualsivoglia principio di autorità
disputando agli autori classici il “premio della scienza” e i loro “mille
errori grossolani”.
La
posizione dell’autore è, dunque, chiarissima: non si tratta di disprezzare i
grandi autori del passato, ma di mettere in evidenza le loro debolezze così
come i loro meriti e qualità e, contemporaneamente, promuovere le arti e
soprattutto la letteratura del 17° secolo, ritenuta superiore.
Come
è stato detto, Perrault sostiene una concezione di modernità della letteratura
in cui le idee d’originalità e novità sono del tutto fondamentali. Per
differenziarsi degli autori francesi classici, Perrault decide di sviluppare un
genere che cominciava a essere alla moda nei saloni letterari e mondani del suo
tempo: il racconto. Questo genere era ben visto e apprezzato soprattutto se
presentava degli aspetti d’ingenuità, ovvero se la narrazione era tratta dalla
tradizione popolare. Questo tipo di racconto prenderà il nome di conte des fées. Marc Escola evidenzia
chiaramente l’idea d’originalità che Perrault incarna:
[il genere] è
ciò che s’inventa nella produzione dell’opera e meglio ancora nella sua
ricezione. La nozione di originalità è sottomessa allo stesso spostamento: non
passa attraverso le ‘varianti’ apportate a un modello canonico sempre-già
disponibile, ma attraverso il ritorno di un déjà-vu,
riconosciuto come tale – di in sapere che non è ‘letterario’ e che è quello di
tutti, autonomo dunque dallo sguardo di ogni magistero. […] Importava che il
regime ‘moderno’ fosse inassimilabile alla dottrina dell’imitazione. […] Tutto
il valore di un testo, nel regime moderno che disegna questa finzione, si gioca
dunque ‘a ricezione’, senz’altra mediazione che quella del lettore che prende
il suo posto in una catena d’enunciazioni […].
Il conte des fées: una natura morale?
Nel
17° secolo, i contes des fées avevano
una natura romanzesca e completamente letteraria; erano scritti, in
particolare, da signore dell’alta società, affascinate dall’elemento
spettacolare che, nei contes, si
converte in fiabesco. Perrault va contro la tendenza romanzesca e decide di trascrivere
e rielaborare dei racconti che provengono dalla tradizione popolare orale,
trasmessi generalmente da delle anziane (serve) e raccontati ai bambini: la
versione definitiva di questa raccolta, edita nel 1697 da Claude Barbin,
prenderà il titolo di Storie e racconti
del tempo passato, con delle moralità.
Jean-Michel
Adam e Ute Heidmann mettono in evidenza l’importanza della scelta del titolo
dell’opera in un quadro editoriale – essendo Barbin l’editore di La Fontaine –
e di continuazione della disputa tra gli Antichi e i Moderni:
Egli
[Perrault] inserisce così la sua raccolta in un contesto editoriale preciso e
introduce un effetto di genericità: i
suoi racconti sono anche, in qualche modo, in ragione della presenza delle moralità,
delle fiabe. È attorno alla questione delle “morali” e delle “moralità” che
ruota una grande parte dell’argomentazione di Perrault, sia nella
lettera-dedica-prefazione che nella prefazione dei racconti in versi del 1695
dove egli spiega che queste storie hanno solamente lo scopo di ‘far entrare più
gradevolmente nello spirito e in un modo che istruisca e diverta insieme’ una
‘moralità lodevole e istruttiva’: ‘Ovunque la virtù è ricompensata, e ovunque
il vizio è punito. [I racconti] Tendono tutti a far vedere il vantaggio che si
ha a essere onesti, pazienti, accorti, laboriosi, obbedienti e il male che
arriva a coloro che non lo sono.’
Nella
dedica di Storie e racconti del tempo
passato si possono già incontrare gli obiettivi principali che Perrault si
propone: raccontare delle storie che, anche se sembrano solo delle “bagatelle”
per divertire i lettori, siano accompagnate da un insegnamento morale che possa
favorire l’educazione dei bambini a cui le storie sono – apparentemente –
indirizzate.
[I racconti]
Racchiudono tutti una morale molto sensata, e che si scopre più o meno, secondo
il grado di penetrazione di coloro che leggono; d’altronde, dato che niente
marca tanto la vasta distesa dello spirito come potersi elevare allo stesso
tempo alle più grandi cose, e s’abbassare alle più piccole; non si sarà
sorpresi che nemmeno la Principessa a cui la natura e l’educazione hanno reso
familiare ciò che c’è di più alto disdegni ricevere piacere da delle simili
bagatelle.
È
interessante sottolineare come l’autore focalizzi la sua attenzione sul “grado
di penetrazione di coloro che leggono”, utilizzando “i termini di ‘morale
utile’ e di ‘morale molto sensata’ per designare il/i senso/i nascosto/i” che il lettore deve
cogliere.
Perrault
non sceglie a caso delle narrazioni di origine popolare; al contrario, egli è
del tutto consapevole del loro potere educativo e didattico, nascosto
nell’elaborazione letteraria che si presenta tramite gli elementi dello
spettacolare e del fiabesco. L’autore riconosce, nei racconti popolari, una
forte moralità cristiana che egli considera necessaria all’educazione dei
bambini e, soprattutto, per le giovani donne del suo tempo.
Perrault,
inoltre, sottolinea l’utilità educativa, per una giovane donna dell’alta
società, di conoscere la cultura del popolo:
[…] ma a chi
conviene maggiormente conoscere come vivono i Popoli, se non alle Persone che
il Cielo destina a condurli? Il desiderio di questa conoscenza ha spinto degli
Eroi, e persino degli Eroi della vostra Razza, fin dentro a delle capanne e dei
rifugi, per vederci da vicino, essi stessi, ciò che ci succedeva di più
particolare, questa conoscenza essendo loro parsa necessaria per la loro
perfetta educazione.
L’elemento
fantastico, nei contes des fées di
Perrault, non è mai eccessivamente marcato. Lo scrittore vuole mantenere un
certo grado di verosimiglianza, idea cara al Classicismo, per mettere in
evidenza la riflessione morale, che è sempre staccata dal racconto e scritta in
versi. L’autore esprime l’importanza del concetto di verosimiglianza
direttamente nella dedica di Storie e
racconti del tempo passato, tramite dei versi che non lasciano spazio
all’interpretazione:
Potevo io
meglio scegliere per rendere verosimile
Ciò che la
Fiaba ha d’incredibile?
E mai Fata, un
tempo,
Fece a una
giovane Creatura
Più doni, e
doni squisiti,
Che ve ne ha
fatti la Natura?
Il
passaggio citato è importante al fine di comprendere l’idea poetica di Perrault
e la sua concezione del conte des fées:
lo spettacolare non avrà mai la forza espressiva della verosimiglianza ma può
essere un elemento rappresentativo molto utile per costruire un testo
letterario che possa apportare un insegnamento morale. Per Perrault, dunque, la
letteratura ha un forte ruolo didattico, che si sviluppa accanto agli aspetti
più puramente artistici o di divertimento.
“Barba Blu”: il
Diavolo tentatore e la giustizia divina
Come
è stato già brevemente accennato, la morale è una parte fondamentale dell’opera
letteraria del difensore dei Moderni: nella disputa contro gli Antichi, la sua
preoccupazione non è solamente quella di dare al lettore una “morale utile”, ma
anche di dimostrare la superiorità della morale cristiana su quella pagana.
È
innegabile, tuttavia, che l’autore sia stato ispirato, in parte, da modelli
classici come, ad esempio, “La favola di Amore e Psiche” di Apuleio.
Un’analisi
molto interessante sul rapporto tra Perrault e i modelli classici è stata
scritta da Ute Heidmann, che propone un parallelismo tra “La favola di Amore e
Psiche”, Gli amori di Psiche e Cupido
di La Fontaine e il racconto “Barba Blu” di Perrault. Heidmann sostiene che
Perrault abbia costruito il personaggio di Barba Blu a partire da una
contaminazione tra l’Amore di La Fontaine e la Venere di Apuleio:
Barba Blu
esercita il suo potere tramite un mazzo di chiavi e una chiave in particolare
arrogandosi un’autorità quasi divina che assomiglia fortemente a quella di
Venere. […] Perrault ha cura di situare il suo personaggio dagli attributi
mitologici in un ambiente “realista” che numerosi dettagli fanno riconoscere
come proprio della sua epoca.
Non
sono del tutto d’accordo con l’analisi di Heidmann. Secondo me, il
personaggio di Barba Blu si ispira, in parte, a un’altra divinità della
mitologia greca: Pan. L’enorme carica erotica e sessuale che Perrault
attribuisce a Barba Blu, riconosciuta anche da Heidmann, unita alla descrizione
del personaggio e del suo metodo per conquistare il cuore di sua moglie, mi
conduce a ritenere Pan come la fonte d’ispirazione per Barba Blu:
Barba Blu, per
fare conoscenza, le portò, con la loro madre e tre o quattro delle loro
migliori amiche e qualche giovane del vicinato, in una delle sue case di
campagna, dove restarono otto giorni interi. Si fecero solo passeggiate,
partite di caccia e di pesca, danze e festini, grandi colazioni: non si dormiva
assolutamente, e si passava tutta la notte a farsi delle malizie gli uni con
gli altri.
Tuttavia,
mi sembra che Pan sia un’ispirazione alterata da un’immagine di origine
cristiana, come sostiene James Hillman nel suo Saggio su Pan:
Tutti gli dei
avevano degli aspetti naturali e potevano essere trovati nella natura, e questo
ha indotto taluni a concludere che l’antica religione mitologica era
essenzialmente una religione naturale, il cui trascendimento da parte del
cristianesimo significò soprattutto la repressione del rappresentante della
natura, Pan, che ben presto divenne il Diavolo dai piedi di capro. […]
Il capro
solitario è infatti sia l’Unico che l’isolamento, una maledetta esistenza
nomadica in luoghi deserti, che il suo appetito rende ancora più deserti, e il
suo canto, ‘tragedia’. […]
Quando l’umano
perde la connessione personale con la natura personificata e l’istinto
personificato, l’immagine di Pan e l’immagine del Diavolo si mescolano.
Mi
sembra che Barba Blu sia una rappresentazione del Diavolo, figura che, come
Hillman spiega, è tratta e adattata dalla mitologia greca e, in particolare, dal
dio Pan. Il personaggio descritto da Perrault presenta i dettagli introdotti da
Hillman, ma con un’accezione cristiana, data dalla presenza delle moralità alla
fine del racconto; l’idea di morale suppone necessariamente un’idea di assoluto
da cui dipendano bene e male, essendo Dio questa idea assoluta, creato
dall’uomo. Un breve passaggio da I fratelli
Karamàzov di Fëdor Dostoevskij descrive chiaramente questa nozione: “se
infatti non esiste il Dio infinito, allora non c’è neanche la virtù, e non ce
n’è neanche bisogno, allora”.
Barba
Blu è dunque il Diavolo tentatore e persecutore, colui che “proibendole [alla
moglie] di aprire lo stanzino nell’ ‘appartamento in basso’, tenta la curiosità
della giovane donna con la stessa perfidia con cui Venere invia Psiche negli
inferi a cercare uno scrigno di belletto di bellezza divina, […] proibendole di
aprirlo”.
Un
altro elemento che mi conduce a vedere Barba Blu come allegoria del Diavolo/Pan
è la descrizione del movimento del personaggio; nel racconto, si può notare
come il protagonista resti sempre allo stesso livello di altezza spaziale; la
sua vera personalità è nascosta nell’ ‘appartamento in basso’, che ricorda
l’abitazione di Lucifero o le grotte di Pan: “le ‘oscure caverne’ dove lo si
poteva incontrare […] furono dilatate dai neoplatonici fino a indicare i
recessi materiali in cui risiede l’impulso, gli oscuri fori della psiche da cui
nascono desiderio e panico”.
Una
volta deciso a uccidere sua moglie, Barba Blu non sale mai al piano superiore
della sua abitazione, da dove la donna prega al soccorso, dimostrando così un
rifiuto totale a distaccarsi dalla propria spazialità:
Tuttavia,
Barba Blu teneva in mano un gran coltellaccio, urlava a sua moglie con tutta la
sua forza, scendi presto, o salirò lassù. […] Scendi velocemente, urlava Barba
Blu, o salirò lassù. […] Non vuoi scendere, urlava Barba Blu. […] Barba Blu si
mise a urlare così forte che tutta la casa tremò. La povera donna scese. […]
In
questo racconto, Perrault presenta al lettore il tema della curiositas. Prima di divenire un
elemento di riflessione tipicamente cristiano – l’esempio più poeticamente
riuscito lo si ha con la storia di Ulisse nella Divina Commedia di Dante Alighieri– questo era un topos della letteratura antica. Perrault, seguendo il modello
classico, condanna la curiosità:
La curiosità,
malgrado tutte le sue attrazioni,
Costa ben
spesso dei rimpianti;
Se ne vedono,
tutti i giorni, numerosi esempi apparire.
È, non ne
dispiaccia al sesso, un piacere ben leggero.
Da quando lo
si prende, cessa di essere.
E sempre costa
troppo caro.
Perrault,
ciononostante, vuole modernizzare il suo racconto e renderlo utile ed
educativo: ecco perché decide di inserire la scena della preghiera e della
lotta della sposa di Barba Blu che, d’accordo con sua sorella, chiede soccorso
ai suoi fratelli, dei cavalieri che, infine, uccidono il malvagio marito.
La
curiosità trasgressiva non costituisce, come afferma Heidmann, un “atto di
sopravvivenza necessario in una società che sacrifica le sue ragazze nubili
‘vendendole’”,
ma è piuttosto un richiamo a “servirsi dei nostri lumi”.
La
moglie di Barba Blu fa parte di coloro “che la ragion sommettono al talento”; lasciandosi persuadere
dalle grandi feste organizzate da Barba Blu, la giovane donna non utilizza lo
spirito della sua ragione e consente a sposare Barba Blu, poiché “cominciò a
trovare che il padrone del luogo non aveva più la barba così blu, e che era un
uomo molto onesto”. Questa era la vera possibilità che la giovane donna aveva
di utilizzare la ragione per evitare un matrimonio pericoloso.
La
morale cristiana concentra la sua attenzione in particolare su tutto ciò che non si deve fare. Gli insegnamenti
morali che Perrault esprime trovano il loro fondamento in un modello che, con
una esposizione più o meno diretta, presenta sempre una frase negativa –
esplicita o implicita – dove si ha una “fabbricazione dell’ideale”: non si deve.
Perrault
lascia intendere un’idea di giustizia divina totalizzante. Nel racconto, il
lettore non ha mai la possibilità di vedere la storia dal punto di vista di
Barba Blu. La terza persona singolare che l’autore utilizza ha la funzione di
nascondere, in realtà in modo non veramente efficace, la vera prospettiva di
osservazione, quella della giovane sposa. Attraverso un sentimento di empatia
con la protagonista, il lettore riconosce istantaneamente Barba Blu come il nemico o, per utilizzare un termine
narratologico, l’antagonista.
Barba
Blu è dunque il personaggio malvagio a
priori e la giovane donna la rappresentante del bene e del buono. Nietzsche
spiega, in un modo che potrebbe essere considerato polemico, il ragionamento
che conduce a questa prospettiva:
E l’impotenza
che non si prende la rivalsa, deve essere falsata in “bontà”; la timorosa
abiezione in “umiltà”; la sottomissione dinanzi a coloro che odiamo in
“obbedienza” (obbedienza, cioè, a uno che dicono imponga questa sottomissione –
lo chiamano Dio). L’inoffensività del debole, la stessa codardia di cui costui
è ricco, il suo stare alla finestra, il suo inevitabile dover aspettare,
acquista ora un buon nome, in quanto “pazienza”, e viene altresì a significare la virtù stessa; […] forse questa
miseria sarebbe altresì una preparazione, una prova, un ammaestramento, e forse
ancora di più – qualcosa che un giorno verrà compensato e pagato con enormi
interessi in oro, ma che dico! in felicità. Ed essi chiamano tutto ciò
“beatitudine”. […] Odo soltanto ora quel che essi già tanto spesso dicevano:
“Noi buoni – noi siamo i giusti” – a
quel che pretendono non dànno il nome di rivalsa, bensì di “trionfo della giustizia”; quel che essi odiano non è
il loro nemico, no! Essi odiano “l’ingiustizia”, “l’empietà”; quel che credono
e sperano, non è la speranza della vendetta, l’ebbrezza della dolce vendetta
(“più dolce del miele” – già la chiamava Omero), bensì la vittoria di Dio, del
Dio giusto sugli empi.
Tutti
questi elementi sono presenti nel personaggio della giovane sposa che, a parer
mio, incarna ed esplicita un’idea di giustizia totalmente cristiana. Il
semplice fatto che la protagonista, una volta scoperta da suo marito, sia
completamente rassegnata alla morte e gli domandi “un po’ di tempo per pregare
Dio” e che, alla fine, quando vede giungere i suoi fratelli, esclami “Dio sia
lodato”, dimostra un carattere d’impotenza
che si trasforma in domanda di giustizia
divina.
Pensare
che Barba Blu non sia cattivo può risultare immorale:
è doveroso ricordare, però, che l’idea stessa di morale discende da una
prospettiva platonico-cristiana.
Ecco
perché Barba Blu è identificato con il Diavolo/Pan: egli rappresenta ciò che
Nietzsche chiama “il signore”, portatore dell’“ideale aristocratico”, ovvero
cosciente di se stesso in tutta la propria completezza. Barba Blu, accettando
la sua vera natura, arriva a imporre il suo volere su chi, come la giovane
sposa, non è riuscito a rendersi forte.
Questo tipo di personaggio, allora, dà un nuovo significato ai termini “buono”
e “cattivo”, in opposizione alla
concezione del “signore”:
Mentre ogni
morale aristocratica germoglia da un trionfante sì pronunciato a se stessi, la
morale degli schiavi dice fin dal principio no a un “di fuori”, a un “altro”, a
un “non io”: e questo no è la sua
azione creatrice. Questo rovesciamento del giudizio che stabilisce valori –
questo necessario dirigersi
all’esterno, anziché a ritroso verso se stessi – si conviene appunto al ressentiment: la morale degli schiavi ha
bisogno, per la sua nascita, sempre e in primo luogo di un mondo opposto ed
esteriore, ha bisogno, per esprimerci in termini psicologici, di stimoli
esterni per potere in generale agire – la sua azione è fondamentalmente una
reazione.
Mi
sembra che il caso della giovane sposa risponda completamente a questa analisi;
in questo racconto, dunque, Perrault propone una morale che, per definizione e
per sviluppo, può essere solamente e fondamentalmente cristiana; una morale che
impone, dall’esterno, delle regole necessarie
di comportamento che sono sempre dialetticamente in opposizione a dei comportamenti differenti.
Per
concludere, ritengo che, presentando al lettore una morale pienamente
cristiana, Perrault riesca nel suo proposito di esaltare l’epoca di Luigi XIV,
un re che, incarnando le idee di potere assoluto
e di diritto divino, rientra perfettamente in questa concezione di morale: il
solo modo, infatti, di soddisfare una società guidata da un potere assoluto, è
di darle una morale che sia, a sua volta, assoluta.
Bibliografia
Adam, Jean-Michel, Heidmann, Ute, « Des genres à la
généricité. L’exemple des contes (Perrault et
les Grimm) », Langages 2004/1 (n° 153).
Alighieri, Dante, « Inferno », Divina Commedia,
Arnoldo Mondadori Editore, collezione I Meridiani, Milano, 1991.
Dostoevskij, Fëdor, I fratelli Karamàzov, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano, 1994.
Escola, Marc, Marc Escola commente : ‘Contes’ de
Charles Perrault, Editions Gallimard, Paris, 2005.
Heidmann, Ute, « Comment faire un conte moderne avec
un conte ancien ? Perrault en dialogue avec
Apulée et La Fontaine », Littérature 2009/1
(n°153).
Heidmann, Ute, « La Barbe bleue palimpseste. Comment
Perrault recourt à Virgile, Scarron et Apulée
en réponse à Boileau », Poétique 2008/2 (n° 154).
Hillman, James, Saggio su Pan, Adelphi Edizioni,
Milano, 1977.
Leopardi, Giacomo, Zibaldone di pensieri, Vol. 1,
Arnoldo Mondadori Editore, Milan, 1983.
Nietzsche, Friedrich, Genealogia della morale, Adelphi Editore, Milano, 1968.
Perrault, Charles, Le siècle de Louis le Grand,
éd. Jean Baptiste Coignard, Paris, 1687.
Perrault, Charles, Histoires ou contes du temps
passé, avec des moralités, éd. Claude Barbin, Paris,
1697.
Note
*Dove non diversamente indicato, le traduzioni delle opere sono da intendersi a cura dell'autore di questo scritto.
Adam, Jean-Michel,
Heidmann, Ute, « Des genres à la généricité. L’exemple des contes (Perrault et
les Grimm) »,
Adam, Jean-Michel,
Heidmann, Ute, « Des genres à la généricité. L’exemple des contes (Perrault et
les Grimm) »,
Heidmann,
Ute, « Comment faire un conte moderne avec un conte ancien ? Perrault en
dialogue avec Apulée et La Fontaine », Littérature 2009/1 (n°153), p.
28.
Per le tematiche di “Barba Blu”, cfr. Heidmann, Ute, « La Barbe bleue
palimpseste. Comment
Perrault recourt à Virgile, Scarron et Apulée en réponse à Boileau », Poétique
2008/2 (n° 154).
Heidmann, Ute, «
Comment faire un conte moderne avec un conte ancien ? Perrault en dialogue avec
Apulée et La Fontaine », Littérature 2009/1 (n°153), op. cit., p. 31.
Heidmann, Ute, «
Comment faire un conte moderne avec un conte ancien ? Perrault en dialogue avec
Apulée et La Fontaine », Littérature 2009/1 (n°153), op. cit., p. 34.