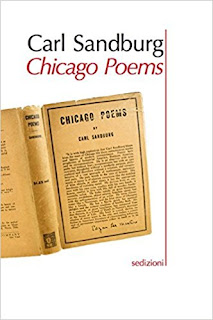In una trattazione che abbraccia ipnosi, sogni, inconscio (sostantivo nell'accezione forte, aggettivale nella versione debole), la matematica di Cantor e Dedekind, Melandri prende avvio dal problema fondamentale della dialettica, ovvero prende le mosse chiedendosi se l'oggetto del discorso possa essere contraddittorio o meno. Sullo sfondo c'è l'urgenza di capire se di un dato oggetto del discorso si può parlare in modo sensato (ad esempio un oggetto che sia contemporaneamente A e non-A risulta contraddittorio e risulta arduo parlarne in modo sensato). La questione si fa interessante se applicata alla psicanalisi e all'inconscio in particolar modo. Cimatti nella postfazione sintetizza il problema chiedendo come è possibile occuparsi dell'inconscio alla maniera di Freud, se "il modo scientifico di conoscere qualunque oggetto si basa su operazioni logico-linguistiche affatto incompatibili con le (presunte) caratteristiche di quello stesso oggetto?" Sullo sfondo, centrale, il problema di come sia possibile parlare dell'inconscio, cioè di qualcosa che sfugge al nostro apparato cognitivo. Nel corso di queste pagine Melandri cerca sostanzialmente di capire (e contestare) l'attributo di illogicità dato da Freud all'inconscio.
La temperatura del ragionamento di Melandri sale allorquando definisce la psicanalisi come interpretazione di manifestazioni neurotiche mediante logoterapia e osserva, se le cose stanno così, come questa diventi una pratica poco convincente che può andare presto a noia. Come può essere che lo psicanalista interpreti o spieghi il sogno o l'atto mancato? E se l'inconscio fosse davvero illogico, come provare a fare su questo un ragionamento scientifico o addirittura, come tenta Melandri, come provare a perseguire l'epistemologia della psicanalisi? Qui s'innesta l'idea regolativa dell'inconscio che secondo Melandri la psicanalisi deve postulare al fine di rincorrere un discorso più efficace e teoreticamente elegante e qui si innesta anche il capovolgimento e contraddittorio rispetto a Freud: non illogico bensì irrazionale è il nostro inconscio, quindi, per definizione, oggetto non catturabile dai nostri strumenti della logica, ovvero dagli stessi strumenti dai quali il discorso era partito. Ma non è possibile rinunciare alla logica per Melandri, mai e poi mai, perché rinunciare alla logica significa precludersi qualsiasi possibilità di conoscenza. Spesso diciamo di un sogno che è assurdo perché vogliamo inquadrarlo in una data logica che non è la sua. In tale cornice ogni evento psichico mantiene una straordinaria autonomia e l'inconscio diventa "obiettivo di un certo sistema di incongruenze".
Come si può dunque conoscere l'inconscio? Innanzitutto serve scalpellare una radicale critica di Freud, laddove riduce l'inconscio a fatto segnatamente linguistico. Per Melandri è venuto il momento di slegare il fatto psichico dall'accento dominante che su di questo esercita il linguaggio. Viva allora la psicanalisi che resta ben salda nel mondo della parola, ma stiamo attenti che la sfera della psiche non si sovrappone a quella del linguaggio, ma è a questa antecedente. E se con Lacan si può arrivare a dire che l'inconscio è strutturato come linguaggio, questo non significa che si possa dire che l'inconscio è linguaggio. Le possibilità conoscitive attorno all'inconscio per Melandri non si possono pertanto fondare su un sapere ancora saldamente logico o saldamente linguistico. Serve un sapere che si apra all'ignoranza, a ciò che sfugge e proprio qui, così, il circolo si salda con la dialettica del titolo di questo saggio. La psicanalisi, nel lacaniano Melandri, si smarca dalla sua centratura linguistica e lo psicanalista diventa colui che propone buone analogie affinché il paziente possa arrivare a pensarsi in modo inedito, scongelato. Come chiude Cimatti la sua postfazione, la psicanalisi così facendo "non dà la parola all'inconscio, al contrario, produce nuovo inconscio, e così facendo inevitabilmente lo rivoluziona."