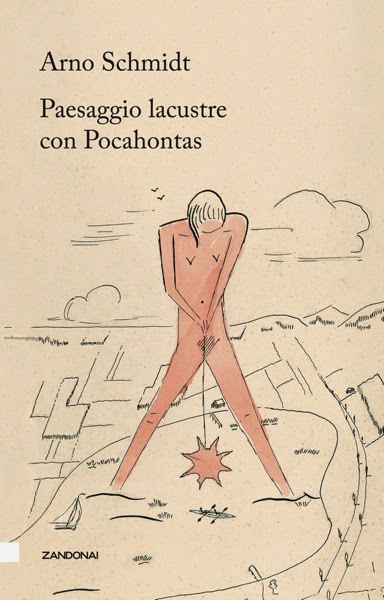Nell’anno
delle celebrazioni del Don Chisciotte (400 anni), la nuova sigla
editoriale Cargo (un piano editoriale nato in seno a l’ancora del mediterraneo)
propone la traduzione de La Saga de los Marx, singolare lavoro datato
1993 di colui che può essere considerato come il più cervantiano tra gli
scrittori spagnoli contemporanei.
Nell’anno
delle celebrazioni del Don Chisciotte (400 anni), la nuova sigla
editoriale Cargo (un piano editoriale nato in seno a l’ancora del mediterraneo)
propone la traduzione de La Saga de los Marx, singolare lavoro datato
1993 di colui che può essere considerato come il più cervantiano tra gli
scrittori spagnoli contemporanei.
Protagonisti di questo libro sono Marx e i suoi
familiari. Il filosofo tedesco, catapultato nel ventesimo secolo, assiste indignato
alla strumentalizzazione e al fallimento del suo pensiero, ai mostri del
‘socialismo reale’ e al disastro del ‘Pensiero Unico’ (leggi: monetarismo). Il
libro è un ironico e anacronistico attacco alla stupidità della civiltà
(‘civiltà’?) della televisione e dello spettacolo. Goytisolo sa come possano
convivere con esiti scoppiettanti la documentazione e l’immaginazione,
quest’ultima così fervida e in grado di non far rimpiangere troppo un
Cervantes.
L’autore appare in veste di scrittore che indaga sulla vita e sul pensiero di Marx. Tutto questo convive col pressing di un editore che esige un libro di successo al più presto, con una soap opera sulla famiglia Marx e talk show popolosi (lo scrittore spagnolo ha dichiarato di aver agito con questo libro in modo contrario a tanti scrittori, mettendo cinema e Tv al servizio della letteratura e dobbiamo riconoscere che ne ha disposto in maniera egregia).
L’esule Goytisolo ha sperimentato con quest’opera, uscita a soli quattro anni dalla caduta del muro di Berlino, l’indifferenza del pubblico spagnolo, quell’indifferenza che può capitare in sorte a opere scomodamente intelligenti, che con grande ironia riescono a raccontare il proprio tempo meglio di voluminosi trattati. Tale situazione è stata forse addolcita dagli apprezzamenti che sono giunti con le traduzioni - più tempestive di quella italiana - pubblicate in Canada, Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Il pubblico italiano non ha che da approfittare di questa traduzione per tuffarsi in un’opera che ha interpretato mirabilmente il clima degli anni in cui è stata scritta.
(Recensione a Karl Marx Show di Juan Goytisolo pubblicata dalla rivista "daemon" nel 2005. Il libro di Goytisolo pubblicato da Cargo è ancora disponibile.)