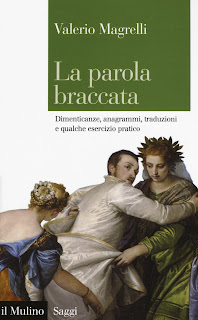L'editore Hacca ha mandato in libreria De l'infinito, universo e mondi. Manuale di esobiologia di Sebastiano Vassalli. Il titolo bruniano cela uno scritto a lungo rimasto inedito, tra le carte dello scrittore. Destinato originariamente a Einaudi, questo testo non ebbe fortuna. Di seguito, per gentile concessione dell'editore e grazie alla puntuale collaborazione di Francesca Chiappa, si propone lo scritto introduttivo di Roberto Cicala, il quale, oltre a fornire un piccolo saggio di storia dell'editoria italiana, colloca quest'opera all'interno della ricerca vassalliana.
Un manuale per
trovare la via del romanzo.
La ricerca di
Vassalli tra poesia e fantascienza a cavallo del Sessantotto
«Fuori del libro nell’universo dei sogni, un universo di morte» è la
visione apocalittica che segna la parabola di Sebastiano Vassalli a cavallo del
Sessantotto nelle pagine del Millennio che muore, forse il
punto lirico più alto del giovane autore d’avanguardia che, non va dimenticato,
nasce proprio come poeta con Lui (Egli) pubblicato nel 1965 da
Rebellato. Fin dal titolo della sua prima plaquette l’idea di «annullare l’io»
predominante in tutta la letteratura tradizionale è uno degli imperativi
categorici del contestatore che riceve il battesimo dal Gruppo 63 in un
incontro a Fano alla vigilia di quel 1968 in cui esordisce nel catalogo Einaudi
con l’«euforica bisboccia verbale sconnessa e avvampante» rilevata da Giorgio
Manganelli in Narcisso, anche se è Giorgio Bárberi Squarotti a
segnalarlo per primo al gruppo della collana dello Struzzo “La ricerca
letteraria” dalla tipica copertina rosa shocking.
Eppure i versi del «millennio che muore, un canto corale, armonioso,
possente, di morte su un universo di individui e di cose che esistono senza
essere» sono schegge di quel tronco di fantascienza che il giovane autore prova
a intagliare con un’impostazione creativa che l’attuale scoperta del Manuale
di esobiologia dimostra d’essere, nella bibliografia vassalliana, non
una semplice curiosità ma un passaggio nodale nella ricerca di una via nuova
per l’urgenza di una scrittura in quegli anni avvertita come «macaronico
inganno, sontuosa, carnevalesca dissimulazione di un’idea di morte, di cosmica
vacuità». Lo ammetterà sulla soglia dei settant’anni: «Il mio percorso per
diventare scrittore è stato lungo e inutilmente tortuoso. Vorrei aver seguito
un altro percorso; ma vivevo in quell’epoca, e non potevo tirarmene fuori».
Vent’anni prima della Chimera il trentenne intellettuale,
nato a Genova ma residente a Novara da quando ha pochi anni di vita, ha una
laurea in lettere con una tesi sull’arte contemporanea e la psicanalisi
discussa con Cesare Musatti e si mantiene insegnando, mentre dipinge e
organizza eventi artistici della neoavanguardia. Sono anni da lui
definiti «straordinari e straordinariamente inconcludenti», in cui si cimenta
anche come editore in proprio con le sigle C.d.E. (Centro di documentazione
estetica) e poi, nel segno dell’«anti editoria», Ant. Ed, cui intesta anche una
rivista underground costituita da un grande foglio piegato in 20 facciate. Se
l’editoria in proprio è una modalità per incontrare i lettori senza sottostare
alle logiche delle grandi case editrici, e senza cadere nell’omologazione
culturale, il terreno argilloso delle riviste è il campo privilegiato per
seminare tutte le idee possibili: nel solco della torinese “Geiger” dei
fratelli Spatola, della leccese “Gramma” e della fiorentina “Salvo imprevisti”
coltiva il progetto controverso di “Pianura”, che però abbandona presto sebbene
il nome resta un’identità forte nel suo percorso, cercando sempre di andare
oltre quegli orizzonti piatti, quel «non-tuttoe-il-contrario-di-tutto tenuto
insieme dalle idee confuse ma forti di quegli anni».
I testi ora scoperti grazie al lavoro di ordinamento dell’archivio che lo
scrittore ha donato al Centro Novarese di Studi Letterari permettono di
ricostruire questo momento di passaggio e di «contraddizioni di una generazione
che si era illusa di cambiare il mondo» e che ha nel Millennio che
muore un «punto d’arrivo e di partenza verso nuovi, inesplorati
territori», secondo il suo migliore osservatore editoriale in presa diretta,
l’einaudiano Guido Davico Bonino, al quale Sebastiano Vassalli rivela in una
lettera del 199, terminata la stesura di Tempo di màssacro, di
«sprofondare negli abissi del macro-microcosmo fantascientifico alla ricerca
del “genere” romanzo». È una rivelazione di grande importanza per il giovane
insegnante che nel fatidico 198 va a vivere con la futura moglie a Casa Bossi
che avrebbe raccontato decenni dopo in Cuore di pietra: così gli
studi e le letture di science fiction – la definizione coniata
dalla rivista “Amazing Stories” negli anni venti poi tradotta in Italia come
«fantascienza» nel 1952, quando inizia a uscire “Urania” – sembrano
una via di fuga per smarcarsi da certa neoavanguardia artistica che lo ingabbia
dentro la «cappa dell’irregolare e del violento contro Dio, natura e arte».
L’idea è di tentare, si legge in altra lettera a Davico, «una sorta di
operazione alchemica, difficile e complessa quanto la tradizionale quadratura
del circolo: una letteratura d’avanguardia che possa essere veramente
“popolare”».
È in quest’ottica che il giovane scrittore impegnato (iscritto al partito
comunista da cui rimane ben presto deluso) avverte l’importanza di
un’impostazione teorica del problema letterario che gli sta a cuore, suggerita
forse dal lavoro di supplente e dalla collaborazione con Einaudi come curatore
di edizioni per la scuola a partire da Il giorno della civetta di
Sciascia (poi Dolci, Viganò, Tobino, Malcom X, Revelli e Gramsci), sebbene il
suo approccio teorico segua sempre canoni postmoderni influenzati dalla
neoavanguardia, come la dialettica di prestiti linguistici alti e bassi con
esasperazione stilistica in chiave satirica. Nascono così due opere legate alla
fantascienza: il Manuale di esobiologia, rimasto sepolto fino ad
ora nella rivista internazionale “Pianeta” e proposto in cinque puntate tra il
1971 e il 1973 con una parte del tutto inedita, e Sesso®. Piccola
enciclopedia universale di fantasesso, di cui Vassalli si finge traduttore
e curatore attribuendo l’opera a tale Stephen Blacktorn, autore d’invenzione
definito «studioso tra i più quotati di esobiologia e di genetica comparata»,
pubblicata nel 1970 dalla casa editrice Dellavalle di Piero Femore e Vittorio
Viarengo, già promotori delle torinesi Edizioni dell’Albero. Ora le due opere
si possono legare finalmente tra loro, non soltanto per il taglio di caricatura
rispetto ai libri fantascientifici di quegli anni. Soprattutto la ricerca
sul Manuale, la cui non facile edizione è ora disponibile per la
cura attenta di Martina Vodola, permette di dare un nuovo senso al segmento di
produzione a cavallo del 1970. Va infatti messa a fuoco un’attenzione verso il
genere manualistico quasi esasperata, perché vissuta da Vassalli come
imprescindibile per impostare una cassetta di strumenti narrativi per il
futuro, da Tempo di màssacro, sul cliché della trattatistica barocca
ma deformata, scelto da Italo Calvino per i primi titoli della sua collana
“Einaudi Letteratura” nel 1970, fino a Manuale di corpo, passando
per i due testi fantascientifici, rifiutati da Einaudi.
Un terzo rifiuto dello Struzzo, in verità contro il parere favorevole di
Manganelli, riguarda un altro manuale, AA. Il libro
dell’utopia ceramica, scritto anch’esso nel 1970 e pubblicato quattro anni
dopo da Longo in «una collana gestita dagli autori stessi»: anche qui predomina
la tensione millenaristica e universalistica, dal momento che l’«utopia
ceramica» significa dare metaforicamente un ordine al mondo ricoprendolo di
piastrelle, nel senso di una «figurazione piana, bidimensionale» in grado di
riprodurre la Storia, non nella sua interezza, ma per allusioni, «per frammenti
riflessi, in Mitologie e Utopie». È l’impresa di un io narrante che colleziona
piccoli esagoni di ceramica ma «non più protagonista» della «ceramizzazione del
mondo». E la figura di un collezionista appare anche nelle pagine del Manuale
di corpo ovvero Sentenze di scrittori antichi e moderni, scritto nel 1972 e
rimasto inedito fino al 1983. Dopo la pubblicazione nei senesi Quaderni di
Barbablù sarà Leonardo Mondadori a riproporlo nel 1991 con l’osservazione
dell’autore secondo cui l’operetta «contiene in sé le ragioni migliori
dell’avanguardia (prima fra tutte, l’idea di letteratura come corpo di parole),
e contiene anche le ragioni che allora mi spingevano a cercare altre strade,
fuori da quella che avevo percorso fin lì e che vedevo essere senza sbocchi».
Uno sbocco intermedio si trova nel successivo Abitare il vento,
tra le prime prove narrative in cui alla fine il protagonista Cris si impicca,
nel senso di una morte necessaria dell’io poetico tradizionale per rinascere e
ripartire senza più la stessa prima persona verbale, in questo caso dopo
l’illusione ideologica della stagione dell’avanguardia che Vassalli vuole
chiudere con la scelta di «abitare il vento», azzerare la situazione presente,
alzare la posta in gioco secondo un’immagine di libertà tratta dal Libro
dei Proverbi: «Chi distrugge la propria casa abiterà il vento». Vassalli
sceglie quindi il mestiere di scrittore passando prima dagli esercizi
manualistici, poi indagando in archivi e provando anche il genere del reportage
(dapprima sugli italiani in Alto Adige), soprattutto però mettendo a frutto le
intuizioni di un libro del «maestro e amico» Giulio Bollati su L’italiano.
Il carattere nazionale come storia e invenzione. Trova così la propria
strada inseguendo personaggi sconfitti, dal fascista semianalfabeta Benito
dell’Arrivo della lozione al comunista Augusto Ricci di Mareblù,
preannunci dei personaggi Antonia, Mattio e molti altri, a partire da uno puro,
il suo «babbo matto» Dino Campana, protagonista della Notte della
cometa, la prima opera della sua maturità nel segno della ricerca storica e
della narrativa. Già in una lettera indirizzata all’Einaudi aveva confessato di
sentirsi «assolutamente consapevole, per quanto mi riguarda, di aver imboccato
la via stretta che conduce chissà dove, forse da nessuna parte: cioè di essere
uno scrittore».
Il florilegio trattatistico di biologia aliena al centro della riscoperta
di questo momento creativo di passaggio è un catalogo di vegetali e animali
extraterrestri compilato per costruire «una visione non del “mondo” – termine
quanto mai ambiguo e polivalente – ma dell’Universo: ché l’epoca delle “visioni
del mondo”, come quella dei “protagonisti” autori di tali visioni è trascorsa».
Lo sbocco della science fiction è infatti uno dei generi possibili
da lui individuati in anni di crisi per trovare una vocazione alla scrittura
narrativa dopo aver accantonato il progetto di fare il pittore o soltanto il
poeta. La parabola del «viaggiatore nel tempo» Vassalli prenderà tuttavia
un’altra strada, proiettandosi nel passato anziché nel futuro, eppure la semina
fantascientifica (che trova un riscontro bibliografico anche in un racconto
pubblicato in un volume della Grande Enciclopedia della
Fantascienza del 1980 curata di Francesco Paolo Conte) porterà frutti
anche in seguito, sempre evidenziando il contrasto fra l’io e l’umanità come
dilemma e conflitto tanto sociale quanto letterario.
La fantascienza, a suo tempo coltivata per liberarla dalle restrizioni di
genere minore, torna sulla scrivania di Vassalli negli anni novanta con il
dibattuto romanzo 3012, che in qualche modo si beffa di chi gli
aveva «contristato l’anima per anni con l’etichetta di romanziere storico». E
senz’altro alla stesura del libro non sono estranei i suoi cataloghi di
«esobiologia» (dove «eso-» deriva dal greco e sta per ciò che è «esterno»,
appunto extraterrestre) e di «fantasesso» essendo ricchi di suggestioni circa
personaggi e situazioni. Per esempio echi dell’Albergo Intergalattico citato
nel Manuale «costruito sugli stessi princìpi degli alveari»
con «le stanze comunicanti che comunicano in realtà verso l’alto o verso il
basso, senza eccezioni» tornano nella descrizione dei «trasferitori» che
permettono gli spostamenti nei Blocchi residenziali dove ha vissuto Antalo, il
protagonista di 3012 in cui dominano le tensioni belliche, i
conflittuali rapporti interpersonali e le sovrastrutture di ogni società con
l’odio come motore delle vicende umane: è una delle tesi presenti nel Manuale
di esobiologia, le cui suggestioni popolano pagine di un’altra opera
narrativa della maturità pubblicata alla vigilia del Duemila, Un
infinito numero, dedicata al viaggio di Virgilio e Mecenate nella terra dei
Rasna alla ricerca delle origini di Roma con la rivelazione della cosmologia
etrusca secondo cui conseguenza necessaria a tutto ciò che viene creato per
popolare il Nulla (termine fondamentale nella visione dello scrittore) è
«l’infiltrazione dell’infelicità». Lo stesso titolo del romanzo rinvia a un
passo dello Zarathustra di Nietzsche – «Tutti gli stati che
questo mondo può raggiungere, li ha già raggiunti, e non una sola volta,
ma un infinito numero di volte» – riportato nel nono capitolo
9 del Manuale, da cui emerge talvolta il medesimo desiderio,
caratterizzante la vocazione primaria di Vassalli, di raccontare storie
dimenticate dalla Storia. Anche in Stella avvelenata, il «Viaggio
anacronismico nell’isola di Atlantide» del 2003, sono raccolti altri frutti
formatisi dai semi gettati decenni prima in De l’infinito, universo e
mondi, come la teoria della pluralità dei mondi e dei loro abitanti esposta
citando a più riprese Niccolò Cusano. Altri riferimenti si trovano nei
racconti, dal Robot di Natale – con l’idea che il desiderio di
conoscere nell’universo una vita aliena derivi dal bisogno di trovare «un
nemico esterno, abbastanza lontano per non rappresentare un pericolo imminente,
ma abbastanza reale per costringerci ad accantonare, in tutto o in parte le
nostre liti domestiche» – fino a La morte di Marx e altri racconti,
dove la visione della contemporaneità è popolata da uomini-macchina dotati di
ruote al posto delle gambe.
Il filo rosso della fantascienza non è quindi un accidente o, meglio, lo è
in senso filosofico, come qualità di un elemento, in questo caso la scrittura,
che può anche mutare nella sua espressione esteriore senza che l’idea
originaria ne venga modificata. Di questo sono una testimonianza ineludibile la
dimensione utopica e tragica presente tanto nella narrativa matura quanto alla
base di questo originale Manuale di esobiologia, forse non riuscito
come genere letterario compiuto ma sorprendente strumento di teoria che
porterà, per esclusioni, alla pratica del romanzo. Vassalli ne sarà un maestro
rappresentando soprattutto alcuni elementi come l’odio e la dolorosa relazione
umana dentro uno spazio apparentemente circoscritto, illuminato sempre da una
visione apocalittica, la stessa del Millennio che muore, di un
mondolibro universale che si decompone per lasciare a tutte le parole la
libertà di rappresentare in modo diverso e nuovo «cose, individui / ciascuno in
grado di vivere nel proprio libro, di scrivere il proprio libro».
Se apocalisse e fantascienza davvero vengono in contatto è questione cui lo
scrittore non dà peso, credendo maggiormente in quanto è ben espresso nella
laica domanda del poeta a lui più vicino, Dino Campana, scelta a esergo
della Notte del lupo: «Qual ponte abbiamo noi gettato
sull’infinito, che tutto ci appare ombra di eternità?».
Roberto Cicala